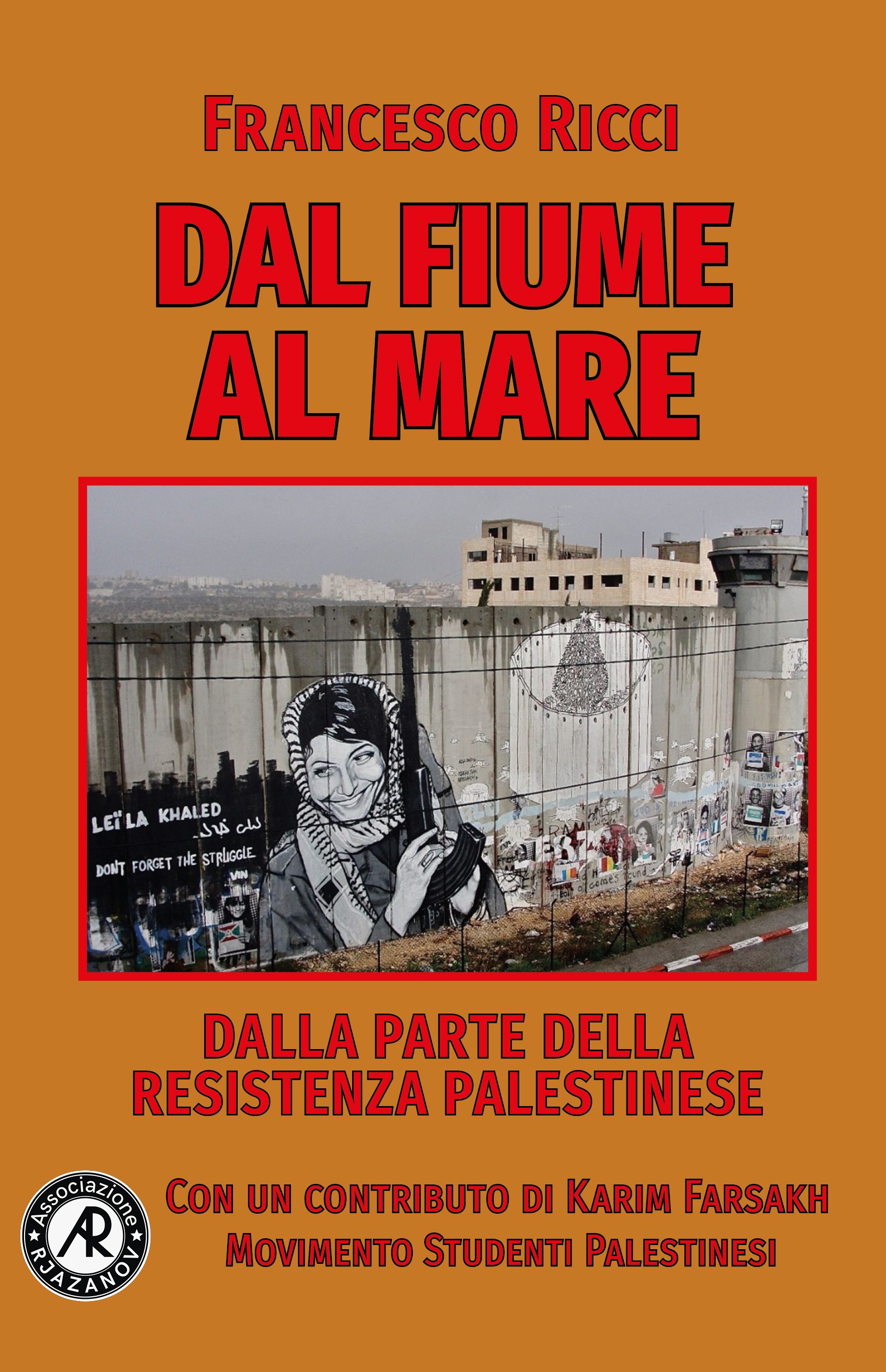Stati Uniti: cosa cambia da Trump a Biden?
di Salvatore de Lorenzo
I partiti liberali e socialdemocratici di tutto il mondo hanno festeggiato la vittoria di Biden contro Trump alle recenti elezioni presidenziali americane, inneggiando allo scampato pericolo di una presunta deriva fascista che gli Stati Uniti avrebbero potuto imboccare se Trump avesse vinto le elezioni. Trump, che non aveva riconosciuto la vittoria di Biden e aveva accusato il Partito democratico (Pd) di frode elettorale, ha chiaramente aizzato i suoi sostenitori di estrema destra a manifestare contro i presunti brogli elettorali, e i fatti del Campidoglio sono una conseguenza soprattutto del clima di tensione creato dal presidente uscente. Tuttavia, l’assoluta mancanza di sostegno da parte dei vertici dell’apparato militare alle provocazioni di Trump indica che non vi era e non vi è alcun pericolo immediato di svolta fascista nel regime borghese americano. La demonizzazione del «fascista» Trump è stata cioè principalmente la tattica propagandistica sistematicamente usata dal Pd per attrarre i voti dei settori più inerti della società americana durante la campagna elettorale.
Non è secondario notare che, pur essendo stato chiaramente sconfitto, Trump ha però ottenuto un numero di consensi superiore a quello con cui aveva vinto le precedenti elezioni e che, se il Pd ha vinto le elezioni, è anche perché ha potuto contare sul sostegno e sulla crescita elettorale dei Democratici di sinistra americani (Dsa), una vera e propria frazione interna al Pd (1) che, pur richiamandosi vagamente agli ideali socialisti sostiene, seppur criticamente, il Pd. I Dsa si collocano nell’area della sinistra riformista mondiale, il cui principale esponente politico negli Usa è Bernie Sanders, che sostiene, in definitiva, la possibilità di costruire un capitalismo dal volto umano (2). Questa frazione ha attratto gran parte dei consensi dei settori più moderati del movimento Black lives matter alla testa delle recenti lotte degli afroamericani, consentendo a Biden di vincere le elezioni. Il paradosso è però evidente: i Dsa, che formalmente rivendicano in prospettiva una società socialista, contemporaneamente appoggiano il principale partito di riferimento dell’imperialismo americano e il suo cinico leader. La storia politica del nuovo presidente statunitense, dall’appoggio al Regno Unito durante la guerra delle Falkland (3) al sostegno dell’intervento militare della Nato in Bosnia-Erzegovina, in Serbia e in Kosovo e all’invasione dell’Iraq (4), fa infatti piazza pulita di tutta l’ipocrita retorica «democratica» dei sostenitori di Biden, in realtà uno dei più sanguinari alfieri di lungo corso dell’imperialismo.
Polarizzazione delle classi sociali negli Usa
Durante la sua presidenza Trump ha ulteriormente contribuito, attraverso una volgare propaganda razzista, maschilista e nazionalista, alla polarizzazione della lotta politica negli Stati Uniti, soffiando demagogicamente sul fuoco delle contraddizioni prodotte dalla irrisolta crisi economica che ha affossato larghi settori di piccola borghesia e peggiorato drammaticamente le condizioni di vita del proletariato americano. Crisi economica da cui, però, il magnate Trump, esponente della grande borghesia, non è riuscito a tirar fuori le classi subalterne. Al contrario, la sua amministrazione ha sostenuto le società multinazionali, attraverso tagli fiscali di diversi trilioni di dollari (5), senza che queste misure potessero produrre una ripresa dell’economia. Durante la sua amministrazione gli Usa hanno vissuto una fase di sostanziale stagnazione dell’economia a cui la pandemia di coronavirus ha assestato il colpo finale producendo il crollo della produttività e i licenziamenti di massa e ridimensionando le illusioni nazionaliste di quei settori delle classi subalterne che avevano sostenuto Trump.
Durante la campagna elettorale, la propaganda razzista di Trump ha consentito a Biden, che al contrario del suo rivale ha mantenuto un atteggiamento più dialogante verso gli afroamericani senza però concedere nulla di sostanziale alle richieste provenienti dalla base del movimento di protesta, di riacquisire consensi in molti settori progressisti e antirazzisti, anche in quelli che non apprezzavano il suo programma moderato. Tuttavia, grazie allo slogan «America first!», Trump è riuscito a mantenere il consenso in larghi settori di classi subalterne, tra cui strati di classe operaia bianca che si rifugiano nel nazionalismo per difendere il loro posto di lavoro, e settori razzisti e reazionari di piccola-borghesia impoverita.
In una fase di accresciute diseguaglianze economiche e di polarizzazione della lotta di classe, la vittoria di Biden è dunque principalmente la conseguenza dell’assenza di un partito rivoluzionario con influenza di massa in grado di orientare il proletariato degli Stati Uniti e i ceti medi più incerti nella direzione di una rottura con lo Stato borghese statunitense.
La fotografia più nitida della crescente polarizzazione della ricchezza negli Usa si deduce dall’analisi dei dati economici: come attestano alcuni istituti di ricerca statunitensi, la quota di ricchezza aggregata detenuta dalla grande borghesia americana è difatti cresciuta a dismisura, passando dal 60% del 1983 all’80% del 2016. La grande borghesia non ha pagato in alcun modo la crisi economica di lungo corso, che si è invece riversata sia sul ceto medio, la cui ricchezza aggregata si è dimezzata, passando, nello stesso periodo, dal 32% al 16%, che sul proletariato, passato dall’8% al 4% (6).
È principalmente sul disagio dei ceti medi che Trump ha alimentato il suo consenso: le organizzazioni militarizzate di estrema destra fasciste e suprematiste bianche (dai Proud Boys a QAnon) si sono apertamente schierate a sostegno di Trump, come i recenti fatti del Campidoglio dimostrano. Oggi queste organizzazioni hanno ancora una rilevanza molto marginale nello scontro tra le classi sociali negli Usa, ma l’impossibilità da parte delle tradizionali forze borghesi di risolvere la crisi economica produrrà inevitabilmente una progressiva crescita delle organizzazioni dell’estrema destra.
Ben più rilevante è stata invece la sollevazione, l’estate scorsa, del proletariato americano, in particolare quello afroamericano e latino, che ha ripreso a lottare sia contro la ghettizzazione dei neri e dei latini che contro la dilagante oppressione razzista della polizia; l’ascesa delle lotte proletarie negli Usa si è alimentata anche del malcontento determinato dalle conseguenze economiche della pandemia di coronavirus negli Usa. I fenomeni insurrezionali innescati dall’omicidio di George Floyd si sono propagati a macchia d’olio in tutto il Paese, producendo oceaniche manifestazioni di massa in tutte le principali città, e hanno raggiunto il culmine con l’occupazione e l’autogestione di un intero quartiere a Capitol Hill da parte degli afroamericani. Anche la classe operaia, che già nel 2019 aveva ripreso la strada degli scioperi prolungati (come lo sciopero degli insegnanti e quello degli operai della General Motors), ha sostenuto, attraverso alcuni scioperi, le manifestazioni di protesta degli afroamericani, che sono state sedate solo per l’intervento violento e repressivo della guardia nazionale e la militarizzazione di intere città. Le manifestazioni sono state, in alcuni casi, molto veementi, costringendo ad esempio il presidente Trump a rifugiarsi nel bunker della Casa Bianca durante i disordini a Washington.
Nonostante il movimento di protesta si sia dotato di parole d’ordine molto radicali, come l’abolizione della polizia, va tuttavia purtroppo notato che un importante settore di Black lives matter, su cui i Dsa esercitano la loro influenza, ha sostenuto l’elezione del «democratico» Biden contro il razzista Trump, nonostante l’antirazzismo di Biden sia solo di facciata e lo stesso Biden, in campagna elettorale, abbia affermato chiaramente di non voler ridurre le spese dello Stato verso la polizia razzista americana.
Ciò nonostante, i nodi della crisi economica non possono essere risolti nel quadro dell’economia capitalistica mondiale, indipendentemente dal fatto che alla guida del governo vi sia un presidente democratico o repubblicano, ed è quindi da attendersi un’ulteriore ascesa della lotta delle classi sociali negli Stati Uniti.
Globalizzazione e crisi economica
Per comprendere le cause della crescente polarizzazione della lotta di classe negli Stati Uniti occorre analizzare i processi che hanno ridisegnato la divisione internazionale del lavoro negli ultimi quarant’anni. La crisi attraversata dai ceti subalterni negli Usa è determinata anche dalla progressiva delocalizzazione della produzione industriale e agricola verso i Paesi dell’Asia e dell’America latina; è, per dirla con Trotsky, la conseguenza dello sviluppo ineguale e combinato dell’economia capitalistica mondiale, che ha consentito alle multinazionali mondiali (americane in testa) di sfruttare il proletariato a basso costo dei Paesi semi-dipendenti dall’imperialismo per la produzione delle merci. Questa gigantesca ridistribuzione della forza-lavoro mondiale ha causato la riduzione numerica di un terzo della classe operaia industriale negli Usa, che è passata dai 18,2 milioni del 1970 ai 12,7 del 2010, accompagnata dalla crescita straordinaria delle forze produttive dei Paesi emergenti: ad esempio, in Cina, la classe operaia manifatturiera si è accresciuta di un fattore cinque, passando da 14,2 milioni del 1970 ai 68,8 milioni del 2010 (7). Uno degli effetti principali della nuova divisione internazionale del lavoro è stato la consistente riduzione del salario nominale minimo dei lavoratori americani (e dei Paesi imperialisti in generale) conducendo a draconiane operazioni di ristrutturazione industriale, come ad esempio alla General Motors, dove i salari sono stati ridotti da 4800 a 2400 dollari (8).
Le misure dell’amministrazione Trump
Il disagio delle classi subalterne è stata la ragione principale sia dell’ascesa del nazionalista Trump alle elezioni presidenziali del 2016 che della sua sostanziale tenuta, in termini di consenso elettorale, nel 2020. Larghi strati di classe media e di proletariato bianco hanno cioè premiato l’idea di fondo del ritorno a una economia nazionale negli Usa. Molte volte, nel corso della storia, gli Stati borghesi nazionali hanno intrapreso politiche protezionistiche, anche se, ad esempio verso la fine dell’Ottocento, queste misure erano funzionali a proteggere un capitalismo nazionale in fase di sviluppo, come accadde nella Germania di Bismark o nell’Italia di Crispi. Come spiegava Rosa Luxemburg in «Riforma sociale o rivoluzione?» quelle misure protezionistiche avevano persino una funzione progressiva, poiché consentivano lo sviluppo delle forze produttive. Le misure protezionistiche che oggi invece applicano i grandi Paesi imperialisti, gli Usa e il Regno Unito su tutti, hanno una finalità diversa. In questi Paesi, il capitalismo, dopo aver raggiunto, da tempo immemore, le punte di massimo sviluppo interno, ha continuato la sua crescita non più all’interno dei confini nazionali, ma estendendosi nei Paesi dipendenti e semi-dipendenti, producendo il progressivo impoverimento dei ceti subalterni dei Paesi imperialisti. Le misure protezionistiche messe in atto nei Paesi imperialisti servono oggi ai partiti borghesi solo da un punto di vista propagandistico, cioè per tentare di attenuare il crescente malcontento delle classi subalterne - determinato dalla riduzione del potere di acquisto dei salari e dalla crescente disoccupazione e precarizzazione della forza-lavoro– attribuendone le cause alle economie concorrenti. Ma, nella realtà, le cose non stanno così: le nascenti borghesie dei Paesi asiatici, ad esempio, hanno sviluppato il capitalismo nazionale ponendosi principalmente al servizio della produzione industriale del capitale finanziario mondiale controllato dai principali imperialismi. È quindi l’imperialismo Usa e i suoi governi, siano essi quello guidato dal Partito repubblicano di Trump o da quello democratico di Biden, a determinare il tracollo delle condizioni materiali degli strati subalterni in Usa. In assenza di un partito rivoluzionario con influenza di massa, i ceti subalterni sono quindi le vittime sacrificali di questa propaganda nazionalista e larghi settori di massa assumono un’ideologia sciovinista, che è però contraria ai loro interessi materiali.
Da un punto di vista economico le misure protezionistiche sono pensate per aiutare le aziende nazionali, i cui costi di produzione sono più elevati rispetto a quelli dei Paesi concorrenti, a vendere i loro prodotti sul mercato interno nel quale, in assenza di protezioni, rimarrebbero invendute per effetto della concorrenza di merci estere con prezzi più bassi. Durante la sua amministrazione Trump ha imposto un regime di tariffe doganali sui prodotti provenienti dalla Cina e successivamente su diversi prodotti provenienti dall’Ue. Queste misure, come commentano diversi analisti economici, si sono però rivelate sostanzialmente inefficaci, in quanto erano state introdotte dall’amministrazione Trump per cercare di ridurre il disavanzo commerciale (differenza tra capitali spesi per l’importazione di merci e capitali guadagnati dall’esportazione) con gli altri Paesi, cosa che ovviamente non è accaduta. Se è vero, difatti, che il disavanzo commerciale con la Cina si è lievemente ridotto, quello globale è addirittura aumentato.
Due ragioni principali hanno determinato l’inefficacia delle misure protezionistiche. La prima è che all’introduzione dei dazi Usa verso i prodotti cinesi il governo cinese ha ovviamente risposto in modo eguale e contrario, introducendo dazi sui prodotti americani e facendo così diminuire il volume di esportazioni dei prodotti americani verso la Cina. La seconda è che tali misure, consentendo alle aziende nazionali di agire in regime di monopolio e quindi di imporre prezzi maggiorati rispetto alla concorrenza, hanno fatto lievitare il prezzo delle merci sul mercato interno, riducendo il potere di acquisto dei consumatori. E lo stesso è accaduto con l’occupazione. Se si analizzano i dati precedenti alla pandemia di coronavirus, si osservava già una riduzione dei posti di lavoro negli Usa (9), il cui salvataggio era stato il leitmotiv del populista Trump nella campagna elettorale del 2016. Ad esempio, la crisi della General Motors, che ha condotto nell’autunno del 2018 alla chiusura di 4 stabilimenti negli Usa e uno in Canada e alla perdita di oltre 14.000 posti di lavoro (10) è anche l’effetto del ridotto export Usa verso la Cina, causato dai contro-dazi cinesi.
La seconda misura dell’amministrazione Trump, finalizzata alla protezione dei prodotti made in Usa, è stata l’imposizione, ai governi di Canada e Messico, di una rivisitazione dei vecchi accordi commerciali di libero scambio, noti come Nafta (North American Free Trade Agreement). Nel luglio del 2020 è stato così ratificato un nuovo accordo commerciale, denominato Usmca (United States-Mexico-Canada), volto essenzialmente a tutelare i prodotti automobilistici e agricoli americani nell’area di scambio dei tre Paesi. L’Usmca impone che solo i veicoli costruiti con il 72% delle componenti prodotte negli Usa non saranno sottoposti a dazi nel mercato comune dei tre Paesi, mentre con il vecchio Nafta era sufficiente che il 62,5% dei componenti fosse made in Usa (11). La misura ulteriore dell’imposizione di un salario minimo di 16 dollari, accolta ovviamente con favore dai sindacati americani, è in realtà stata imposta per porre fuori dalla concorrenza le imprese messicane, che pagano salari molto più bassi ai loro lavoratori. Inoltre, per proteggere gli agricoltori americani, preoccupati dai contro-dazi cinesi sui loro prodotti, Usmca consente ai produttori americani di pollame, formaggi e uova di poter vendere liberamente in Canada.
Questi nuovi accordi, che nascono per tentare di attenuare la crisi delle imprese che producono merci negli Usa, sono però solo palliativi che non potranno risolvere il problema della crescente disoccupazione negli Stati Uniti: oltre che per il motivo strutturale di fondo, cioè la progressiva riduzione del tasso di profitto, anche perché le potenze concorrenti non sono rimaste nel frattempo a guardare, ma si sono impegnate a costruire nuove aree di scambio per i loro prodotti. In particolare, il governo cinese ha portato a compimento tutta una serie di accordi che ampliano considerevolmente il mercato delle sue merci. Dopo un lavoro durato diversi anni, le principali economie asiatiche tra cui lo stesso Giappone, ma anche altri due Paesi come l’Australia e la Nuova Zelanda, hanno difatti ratificato un importante accordo per la creazione di un’enorme area di libero scambio nel Sud-est asiatico. L’accordo, denominato Rcep (Regional comprehensive economic partnership) include complessivamente 15 nazioni (12). Dopo vari tentativi di coinvolgere anche l’India, questa si è sottratta all’ingresso in questa nuova gigantesca area commerciale che, come ha sottolineato baldanzosamente il governo di Pechino, include Paesi che producono circa 1/3 del Pil mondiale. L’obiettivo dell’accordo è quello di rimuovere progressivamente le tariffe sulle importazioni tra i Paesi aderenti. Rcep rappresenta, dal punto di vista capitalistico, la più severa lezione fornita dal governo cinese alle misure protezionistiche adottate dall’imperialismo Usa.
La questione energetica ed ambientale
Se Trump non è riuscito a risolvere i problemi strutturali che hanno condotto all’impoverimento dei ceti medi e del proletariato americano, non sarà certo il ritorno al multilateralismo, invocato da Biden nel suo recente documento programmatico (13), a invertire la rotta. Le future mosse dell’amministrazione Biden andranno nel verso principale di riprendere la rete di relazioni economiche, politiche e militari principalmente con l’Ue e gli altri Paesi capitalisticamente avanzati; relazioni interrotte o messe in crisi dall’isolazionismo voluto dalla precedente amministrazione.
Tra i vari punti dell’agenda programmatica di Biden, una questione centrale è rappresentata dell’accordo di Parigi sul cambiamento climatico. Critiche all’accordo di Parigi, per l’insufficienza delle misure adottate per attenuare il riscaldamento globale, sono state espresse da diversi centri di ricerca internazionali sugli effetti climatici (14) e dal movimento ecologista mondiale Fridays for future. Come descrivono i principali istituti mondiali di ricerca sul clima, per poter ridurre in maniera realmente significativa le emissioni di CO2 in atmosfera occorrerebbe difatti una completa razionalizzazione e pianificazione della produzione mondiale delle merci, che però, come noto, è assolutamente impossibile all’interno di un sistema di produzione anarchico e concorrenziale quale quello capitalista.
Biden ha già comunicato ufficialmente la sua intenzione di rientrare nell’accordo, dopo l’uscita degli Usa per volontà di Trump. Tutta la propaganda delle principali centrali imperialiste sulla riconversione ecologica delle imprese, incluso quella dell’Ue, è solo fumo negli occhi del movimento ecologista globale. In tal senso le altisonanti proposte politiche di Biden non sono molto differenti da quelle dell’Ue. Peraltro, in campagna elettorale, Biden ha cercato di svicolare sugli aspetti più problematici, sui quali si è mostrato invece molto cauto e riluttante. In particolare, Biden ha sostenuto di non voler rinunciare al fracking, cioè a quella nuova procedura di estrazione del petrolio, ad elevatissimo impatto ambientale, che è basata sulla fratturazione di interi volumi di roccia. Come noto, non esiste, dal punto di vista climatico e ambientale, procedura di estrazione del petrolio più devastante del fracking. Attraverso il fracking le principali aziende petrolifere americane hanno già devastato intere regioni degli Stati uniti e dell’America latina, come il bacino del Permiano in Texas e in Messico. Ma per il capitalismo questo è assolutamente secondario: attraverso l’uso di questa nuova tecnologia, in uso a partire dal 2007, gli Stati Uniti sono difatti diventati i principali produttori di petrolio al mondo, occupando una quota di mercato attorno al 25%. Questo incremento della produzione petrolifera ha contribuito a far crollare il prezzo del petrolio sul mercato mondiale. Paradossalmente, però, questo si è rivelato un enorme problema maggiormente per il settore di capitalismo finanziario che controlla l’industria del fracking, poiché la tecnica basata sul fracking ha una rendita economica più bassa delle tecniche convenzionali, a causa dell’elevato costo richiesto per fratturare interi volumi di rocce crostali. Il crollo del prezzo del petrolio ha prodotto una crisi profonda anche nell’industria del fracking: tra il 2015 e il 2019, 175 società del settore energetico hanno cessato l'attività facendo default su circa 100 miliardi di debiti. Come le titubanze di Biden sulla questione dimostrano, è tuttavia davvero poco credibile che i capitalisti americani abbandonino questa devastante tecnologia, che consente loro di mantenere l’egemonia recentemente conquistata nel mercato mondiale dell’energia.
L’altra principale e irrisolta questione ambientale resta quella delle emissioni di CO2. La Cina, con una emissione di 9,8 Gt/anno di CO2, resta la principale responsabile dell’inquinamento globale, seguita dagli Usa (5,4 Gt/anno) (15). Fingendo di dimenticare che una gran parte delle emissioni di CO2 in Cina è collegata alla produzione industriale delle imprese americane, Biden ha affermato però che il problema principale rimane la Cina, in quanto gli Usa «creano solo il 15% delle emissioni globali» e ha quindi annunciato la convocazione di «un vertice dei principali emettitori di carbonio del mondo» affinché la Cina «il più grande emettitore di carbonio al mondo, smetta di sovvenzionare le esportazioni di carbone e di esternalizzare l'inquinamento ad altri Paesi finanziando progetti di energia sporca di combustibili fossili per miliardi di dollari» (13).
Durante la campagna elettorale Biden ha presentato un altisonante piano da 2000 miliardi di dollari per una transizione ecologica che annulli le fonti fossili in 15 anni e che renda gli Stati Uniti un Paese a emissioni zero entro il 2050 affidandosi solo a fonti rinnovabili. Il piano è in realtà funzionale all’imperialismo Usa a ridare ossigeno al sistema di impresa nazionale, soprattutto per i danni causati dalla pandemia, che ha già prodotto una draconiana riduzione del Pil rispetto all’anno precedente e una disoccupazione di massa stimata in 40 milioni (16), paragonabile se non superiore a quella della crisi del 1929. Il richiamo al «new green deal» è cioè pura propaganda, usata da Biden in campagna elettorale per tentare di guadagnare il voto dei settori ecologisti della società americana. Nessuna politica ambientale seria può essere condotta in regime capitalistico e di questo sono ben consapevoli gli ideologi della borghesia americana, come si evince chiaramente dalle animate discussioni in corso sui principali organi di stampa americani (17).
La ripresa del dialogo con l’Ue
Sul fronte internazionale Biden punta a rilanciare e ad infittire gli accordi commerciali con l’Ue, dopo il periodo di relativo isolamento imposto dal protezionismo di Trump. L’idea di fondo è quella di ricostruire un’alleanza transatlantica per sottrarre alla Cina la sua influenza commerciale sui Paesi dell’Ue. Non sarà un’impresa facile per gli Usa, poiché, proprio in questi giorni, Cina ed Ue hanno ampliato il loro rapporto economico e commerciale. Difatti, dopo aver siglato il Rcep, il governo di Pechino ha continuato ad ampliare la rete delle sue relazioni commerciali e industriali e il 5 gennaio ha raggiunto un importante accordo, denominato Cai (Comprehensive Agreement on Investment) proprio con Bruxelles. Alle aziende europee, l’accordo garantisce una maggiore penetrazione nel mercato cinese sia nel settore manifatturiero che in quello della sanità privata, ma anche nel mercato automobilistico e in quello della distribuzione dell’elettricità (18). Per Biden, il Cai costituisce un ulteriore ostacolo sulla strada della ripresa di un rapporto privilegiato con l’Ue, tanto che nel suo documento programmatico, scritto ancor prima che l’accordo andasse a buon fine, aveva lanciato l’idea di convocare un «Summit globale per la democrazia, per rinnovare lo spirito e lo scopo condiviso delle nazioni del mondo libero», con lo scopo di «riunire le democrazie del mondo per rafforzare le nostre istituzioni democratiche, affrontare onestamente le nazioni che si stanno ritirando e forgiare un'agenda comune». L’obiettivo dell’amministrazione statunitense è mantenere il suo ruolo di potenza egemone nel controllo del mercato mondiale, messo in crisi dall’isolazionismo di Trump. È lo stesso Biden a denunciare le difficoltà odierne di controllo statunitense dei mercati mondiali. Nel suo documento programmatico afferma difatti: «I Paesi commerceranno con o senza gli Stati Uniti. La domanda è: chi scrive le regole che governano il commercio? Chi si assicurerà che proteggano i lavoratori, l’ambiente, la trasparenza e i salari della classe media? Gli Stati Uniti, non la Cina, dovrebbero guidare questo sforzo». Al di là della grottesca preoccupazione di Biden per le sorti di lavoratori e ambiente è però evidente la difficoltà della nuova amministrazione di limitare l’influenza economica della Cina sul mercato mondiale.
Per riprendere la rete di relazioni interrotta durante la parentesi trumpiana, Biden si è circondato di diplomatici di alto livello, già testati durante la precedente amministrazione Obama. Ha difatti nominato a direttore della Cia il diplomatico veterano William Burns, il quale ha contribuito, lavorando a stretto contatto con Jake Sullivan, nuovo consigliere per la sicurezza nazionale, a dirigere l’accordo nucleare iraniano del 2015, dal quale in seguito Donald Trump si è ritirato. Tra i primi tweet di Sullivan è emersa esattamente la necessità di sviluppare delle consultazioni con l’Ue relativamente alle «preoccupazioni comuni sulle pratiche economiche della Cina».
L’amministrazione Biden proverà ad esercitare una moral suasion sull'Unione Europea per sottrarla alle sue relazioni con la Cina, dipingendo quest’ultima come uno Stato autoritario e antidemocratico. Che la Cina sia un regime borghese autoritario è assolutamente scontato. Che l’accusa provenga dal più sanguinario imperialismo, che a partire dal dopoguerra ha annientato, l’uno dopo l’altro, tutti i processi rivoluzionari che si sono svolti in ogni angolo del pianeta, è francamente ridicolo.
Nel tentativo di ricostruirsi un look da democratico sostenitore dei diritti umani nel mondo, Biden, che avanza pesanti accuse all’ingerenza cinese ad Hong Kong e Taiwan (19), sta rafforzando i suoi legami con gli ambienti vaticani, ritrovandosi in perfetta sintonia con il gesuita Bergoglio (3), anch’egli, come Biden, estremamente critico nei confronti della repressione cinese degli uiguri (20).
La questione mediorientale
Sul versante mediorientale il problema principale per la nuova amministrazione resta l’Iran, che pure sta attraversando una profonda crisi economica e politica ed è uno degli odierni avamposti della lotta di classe tra il proletariato e la borghesia. Sia dalla scelta di Burns e Sullivan nei posti chiave della futura amministrazione, sia dalle dichiarazioni rilasciate da Biden, emerge la volontà di un rientro negli accordi presi dall’amministrazione Obama nel 2015 e da cui Trump si era defilato.
Tuttavia, Biden ha lasciato intendere che il rientro negli accordi è subordinato alla verifica della reale intenzione dello Stato iraniano di non sviluppare oltre il suo impianto missilistico e il suo arsenale nucleare. La questione di fondo irrisolta resta cioè quella dell’egemonia militare sull’intera area orientale. L’uscita dall’accordo con l’Iran degli Usa, voluta da Trump, aveva rappresentato solo l’inizio di una escalation nella tensione tra il principale baluardo americano in Medioriente, cioè Israele, e l’Iran, come l’omicidio di Soleimani e gli attacchi di Israele di questa estate alle centrali nucleari e alle basi militari dove vengono prodotti i missili balistici iraniani lo dimostrano (21).
Se da un lato, dunque, per non isolarsi dagli altri Paesi imperialisti che mantengono un rapporto più disteso con il regime teocratico di Teheran, Biden resta disponibile a rientrare negli accordi sul nucleare iraniano, egli non potrà, né vorrà, fare altro che proseguire sulla strada del rafforzamento dell’egemonia israeliana sull’area mediorientale, tracciata dal suo predecessore. L’amministrazione Trump ha difatti lavorato, in questi anni, alla normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra le monarchie del golfo ed Israele e al loro riavvicinamento anche sotto la sfera commerciale ed economica. Nel gennaio dello scorso anno Trump aveva definito «l’accordo del secolo» una annessione unilaterale ad Israele di ampi territori della Valle del Giordano, fondamentali per rifornire l’acqua ai palestinesi, e la negazione di ogni diritto di ritorno nelle loro terre dei profughi palestinesi. Già in quell’occasione le monarchie del golfo non si erano espresse contro l’accordo. Pochi mesi prima di lasciare la Casa Bianca, Trump ha poi perfezionato la nuova intesa tra Israele ed Emirati Arabi: Il 15 settembre del 2020 Netanyahu ha difatti sottoscritto, alla Casa Bianca, assieme ai rappresentanti degli Emirati arabi e del Bahrain, l’Accordo di Abramo, un accordo di pace, di cooperazione e di sviluppo di relazioni commerciali tra i Paesi sottoscrittori. Il 23 ottobre del 2020, facendo seguito a questo lavoro, anche il Sudan ha riconosciuto lo Stato di Israele ed è per questo stato rimosso dalla black list degli Stati terroristi (22). Dal tentativo di normalizzazione imperialista dell’area resta fuori al momento un solo attore principale, l’Arabia Saudita, che «ufficialmente non vuole compiere questo passo finché Israele non accetterà il piano di pace con i palestinesi proposto da Riyadh nel 2002» (22).
L’idea di fondo della politica Usa è dunque quella di rafforzare il ruolo nell’area di Israele, sua testa di ponte in Medioriente, attraverso l’alleanza con diversi Stati musulmani. L’Iran, storico nemico di Israele, già danneggiato dalle sanzioni economiche imposte da Trump, ne esce ulteriormente indebolito. Se l’interesse per il petrolio medio-orientale non è più la priorità per gli Stati Uniti, il Medioriente continua però a rappresentare uno snodo fondamentale per il controllo del commercio mondiale, tanto più che, in direzione opposta, progredisce il rafforzamento nella cooperazione economica e, soprattutto, militare tra la Cina e l’Iran, grazie agli accordi stilati nel luglio dello scorso anno (23).
Conclusioni
Dopo aver tracciato alcune delle principali linee della politica estera che Biden implementerà durante il suo mandato, appare evidente che lo scontro capitalistico mondiale in atto sul pianeta, e che si manifesta attualmente sotto la forma di guerre commerciali, è solo agli inizi. L’apparente querelle tra Trump e Biden è solo un tentativo mediatico del capitalismo finanziario statunitense di incanalare il profondo e crescente malcontento del proletariato e delle classi medie nell’alveo della contesa elettorale, all’interno di un sistema elettorale talmente «democratico» da non consentire a cinquanta milioni di immigrati latini e afroamericani di poter esprimere la loro preferenza.
Lo scontro tra capitali mondiali non potrà che approfondirsi per effetto della crisi mondiale dell’economia capitalistica, che ha cause strutturali molto profonde e ha generato l’ascesa della lotta di classe del proletariato in almeno una ventina di Paesi negli ultimi due anni e continua a svilupparsi in nuovi Paesi.
Nessuna ricetta protezionistica impedirà l’acuirsi delle contraddizioni tra i governi borghesi e le classi subalterne impoverite.
Nessun «new green deal» potrà affrontare seriamente, nell’ambito dell’economia capitalistica mondiale, la catastrofe climatica incombente.
Solo se il proletariato mondiale riuscirà, a partire dai tanti fuochi della lotta di classe che si accendono ogni giorno in tutti gli angoli del pianeta, a dotarsi di una direzione socialista e rivoluzionaria, sarà possibile porre fine all’imbarbarimento prodotto dalla competizione imperialistica mondiale e salvare le grandi masse dalla catastrofe che incombe sul nostro pianeta.
Note
(1) https://www.dsausa.org/about-us/what-is-democratic-socialism/
(2) https://www.alternativacomunista.it/politica/internazionale/una-nuova-internazionale-per-opera-di-sanders-e-varoufakis
(3) https://litci.org/es/joe-biden-y-el-papa-francisco-el-nuevo-equipo-del-imperialismo/
(4) https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-politica-estera-di-biden-medio-oriente-un-ritorno-al-passato-26527
(5) https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/08/30/usa-lo-studio-fmi-i-tagli-alle-tasse-di-trump-solo-il-20-dei-risparmi-usato-per-investire-il-resto-e-finito-in-tasca-agli-azionisti/5414352/
(6) Per ricchezza aggregata si intende la percentuale della ricchezza totale di un dato Paese; i dati sono stati pubblicati dal Pew research centre e sono consultabili all'indirizzo: https://pewrsr.ch/34pAP2h
(7) Industrial Development Report 2013 Sustaining Employment Growth: The Role of Manufacturing and Structural Change.
(8) Si veda ad esempio: Salvatore de Lorenzo, «La ripresa della lotta di classe negli Stati uniti d’America», Trotskismo Oggi n.17
(9) https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/accordo-usa-cina-una-tregua-nella-guerra-commerciale-24835
(10) https://ilmanifesto.it/trump-in-panne-con-gm/
(11) https://ilmanifesto.it/il-nuovo-nafta-rida-fiato-a-trump/
(12) https://ilmanifesto.it/vittoria-di-pechino-il-rcep-disegna-lasia-post-trump/
(13) https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-01-23/why-america-must-lead-again
(14) http://www.cittadellascienza.it/centrostudi/2015/12/cop21-di-parigi-sul-clima-da-disastro-annunciato-a-risultato-insperato-2/
(15) https://www.canaleenergia.com/articoli-di-redazione/emissioni-co2-la-classifica-dei-paesi-piu-inquinanti/
(16) https://www.affaritaliani.it/esteri/usa40-milioni-di-disoccupati-un-americano-su-quattro-senza-lavoro-675464.html
(17) Si veda ad esempio: https://www.ft.com/content/a799d226-7bd3-41b9-98db-381fd8b36d64
(18) https://www.lastampa.it/economia/2020/12/30/news/accordo-ue-cina-cosa-cambia-per-l-italia-1.39715319
(19) https://www.ilsole24ore.com/art/biden-non-portera-disgelo-relazioni-usa-e-cina-ADmRUa2
(20) https://www.limesonline.com/notizie-mondo-oggi-24-novembre-trump-biden-transizione-nomine-blinken-papa-francesco-libro-uiguri/121173
(21) https://litci.org/es/el-verano-caliente-de-las-luchas-obreras-en-iran/
(22) https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/pace-fredda-medio-oriente-28701
(23) https://www.nytimes.com/2020/07/11/world/asia/china-iran-trade-military-deal.html