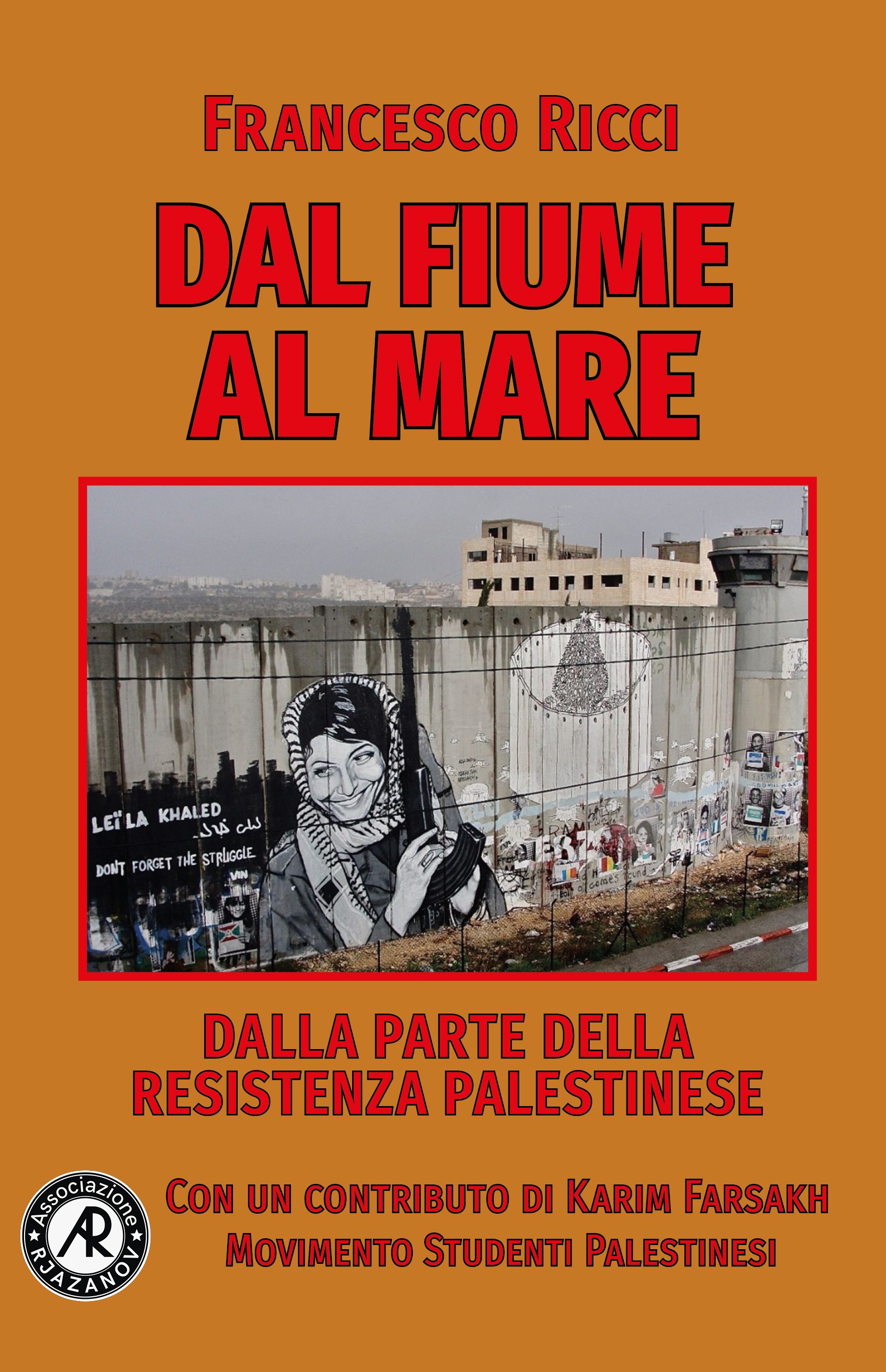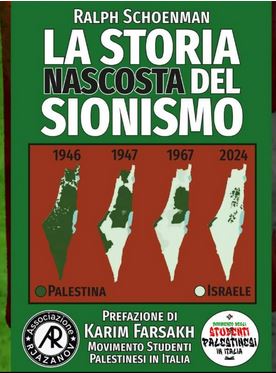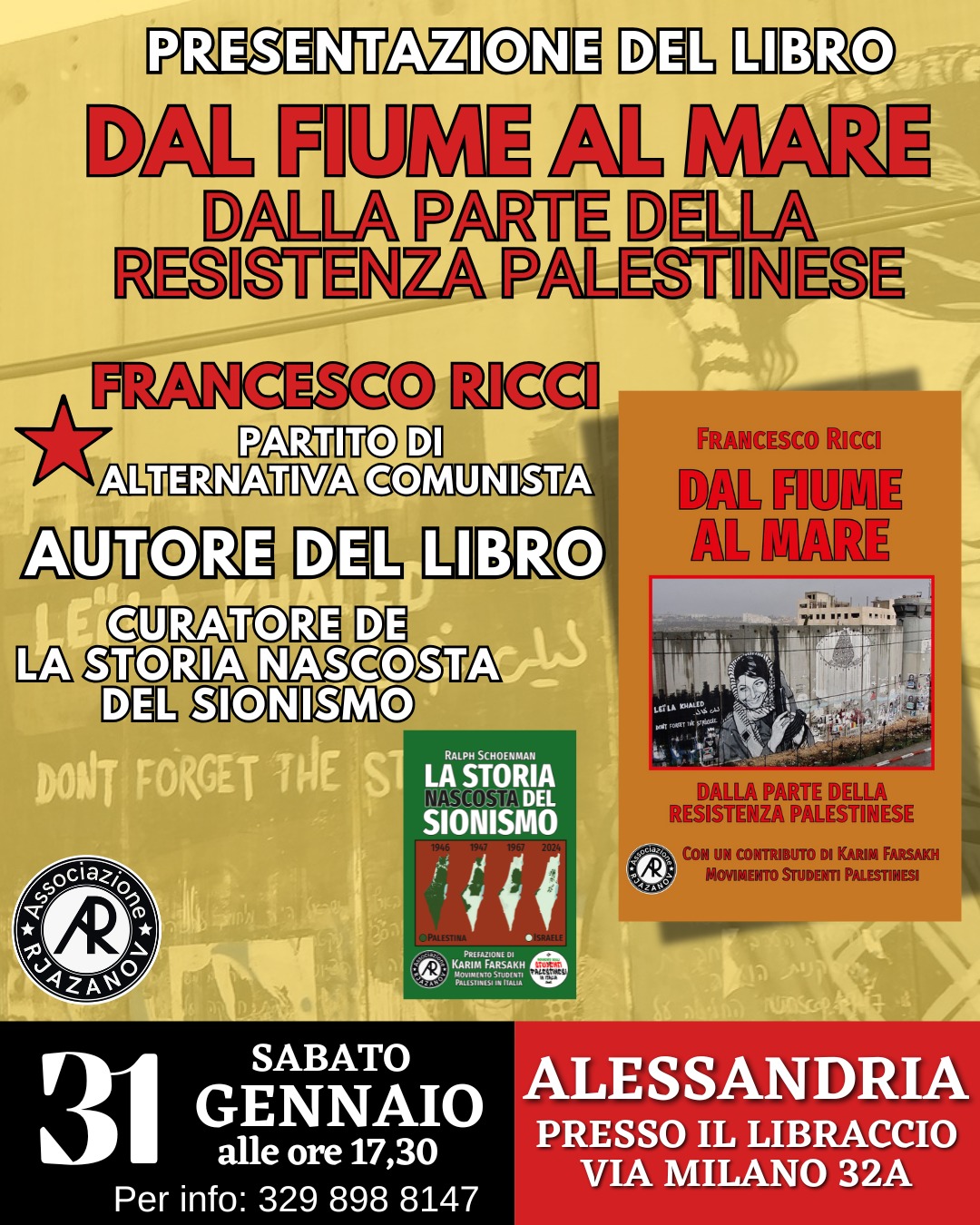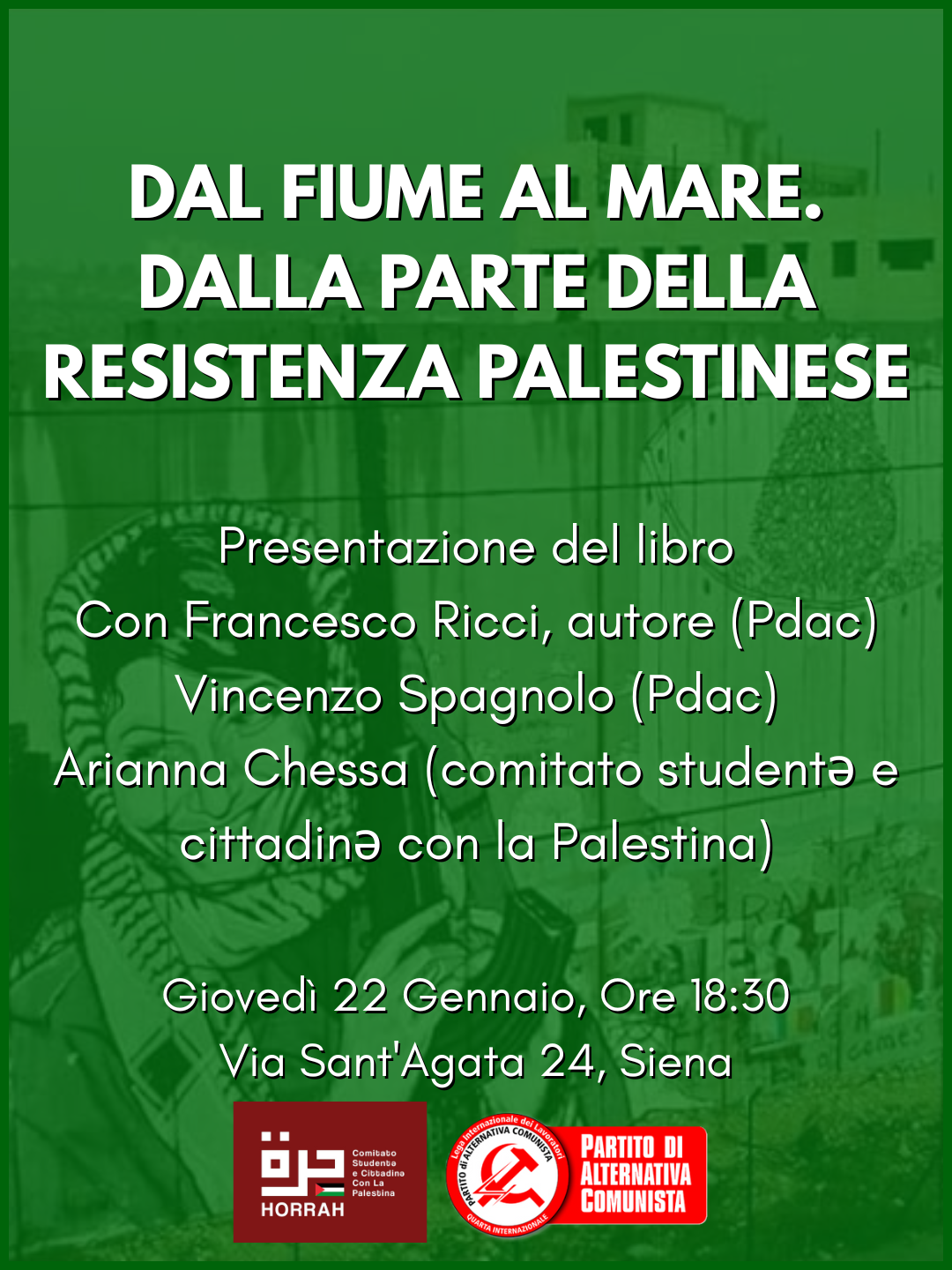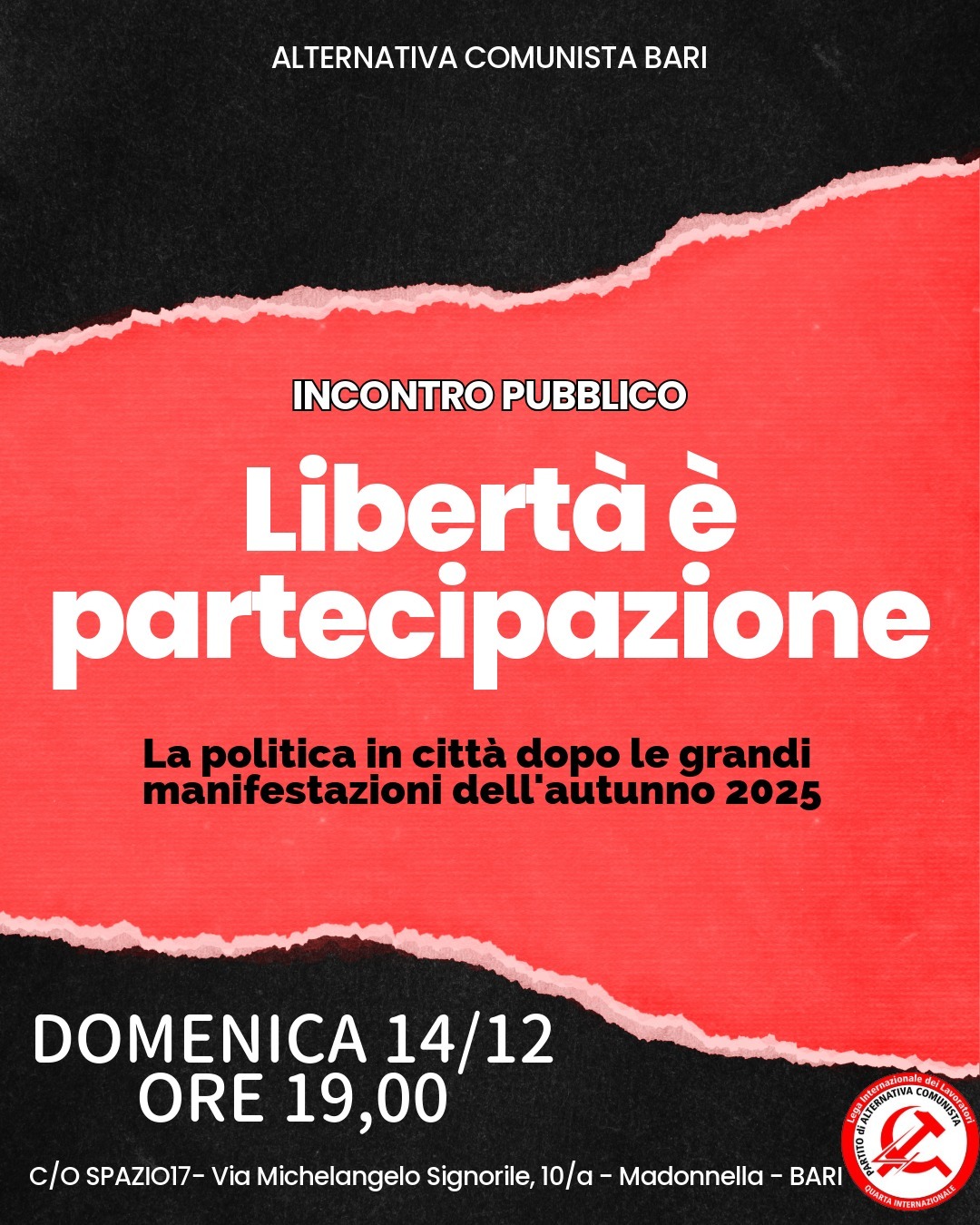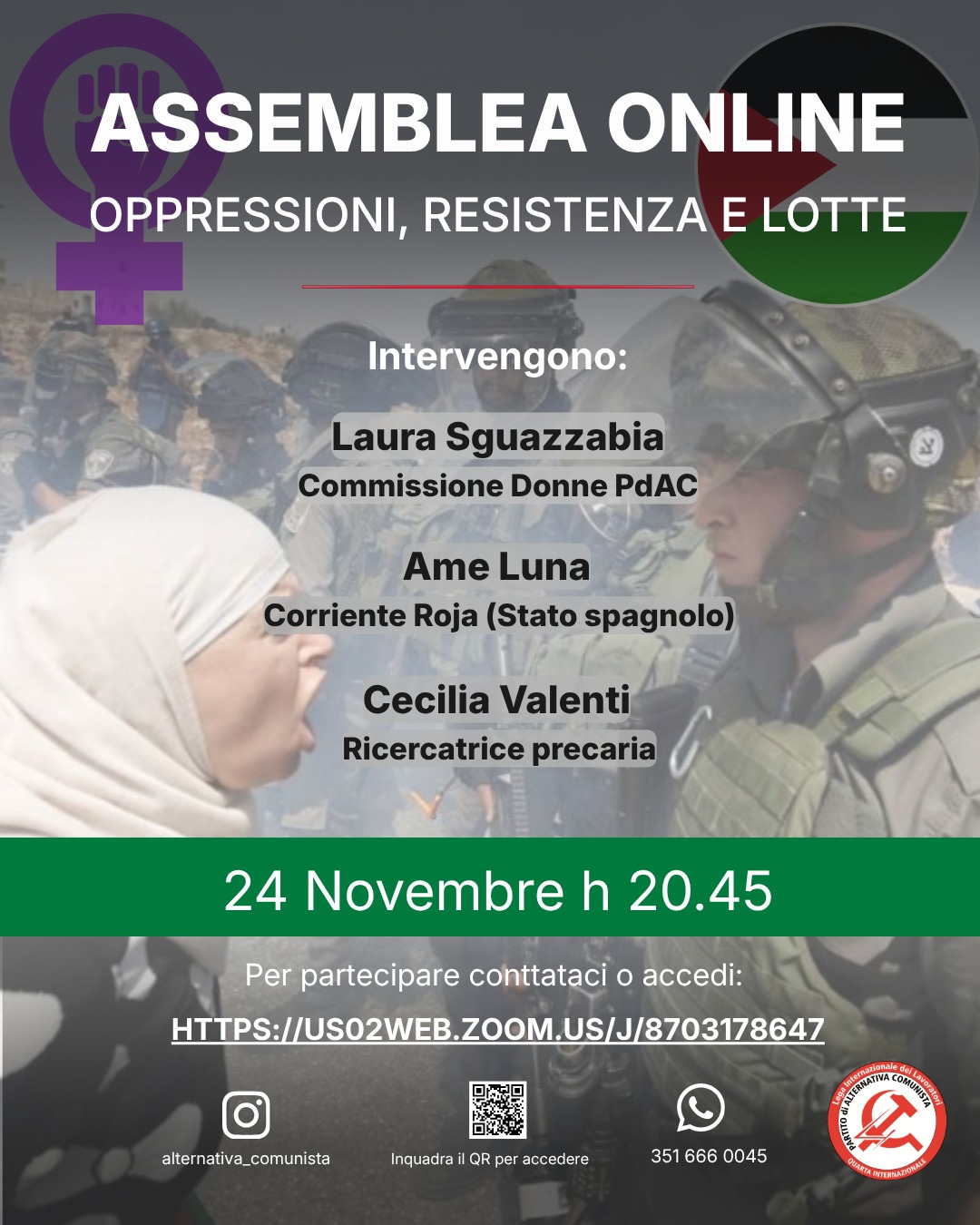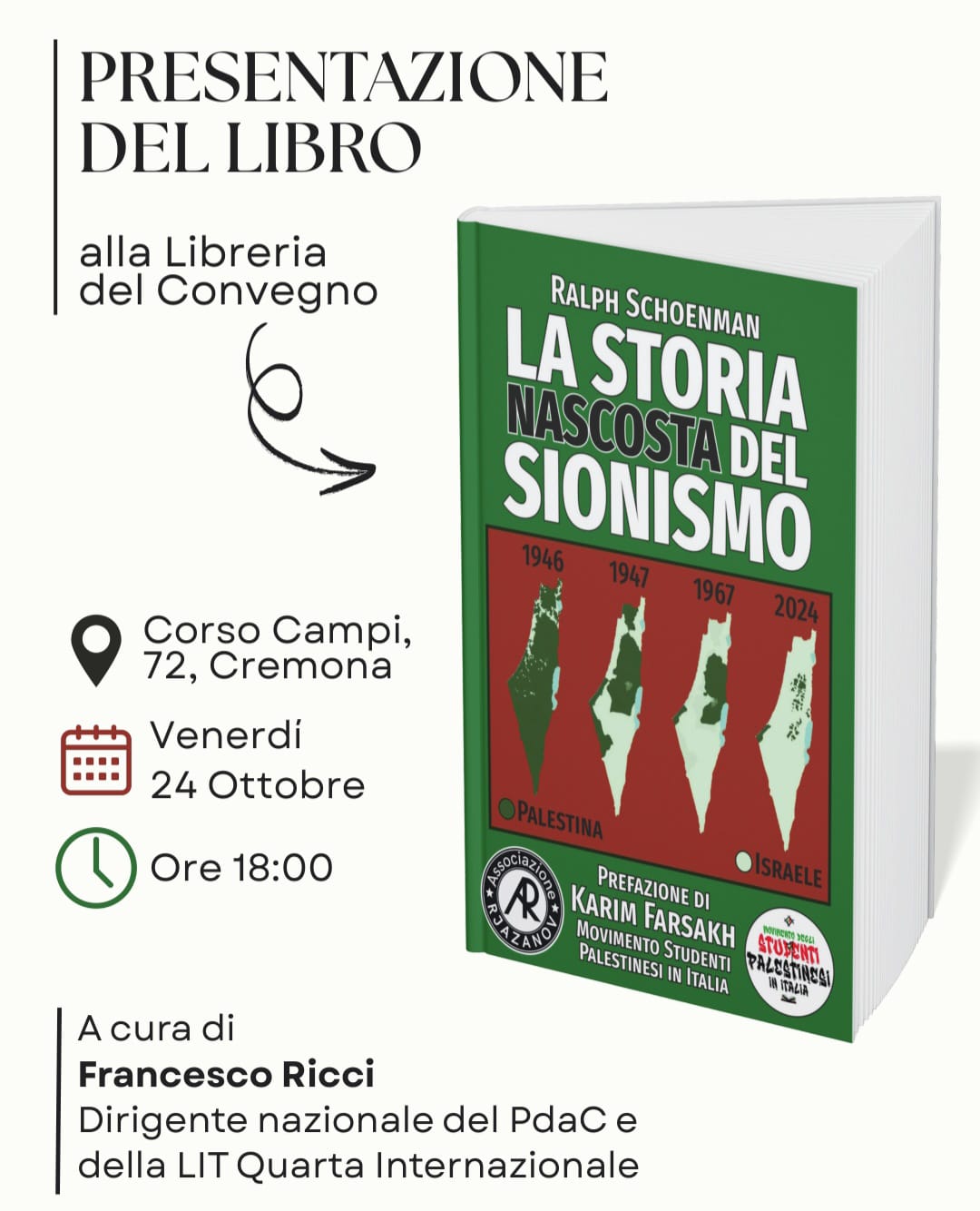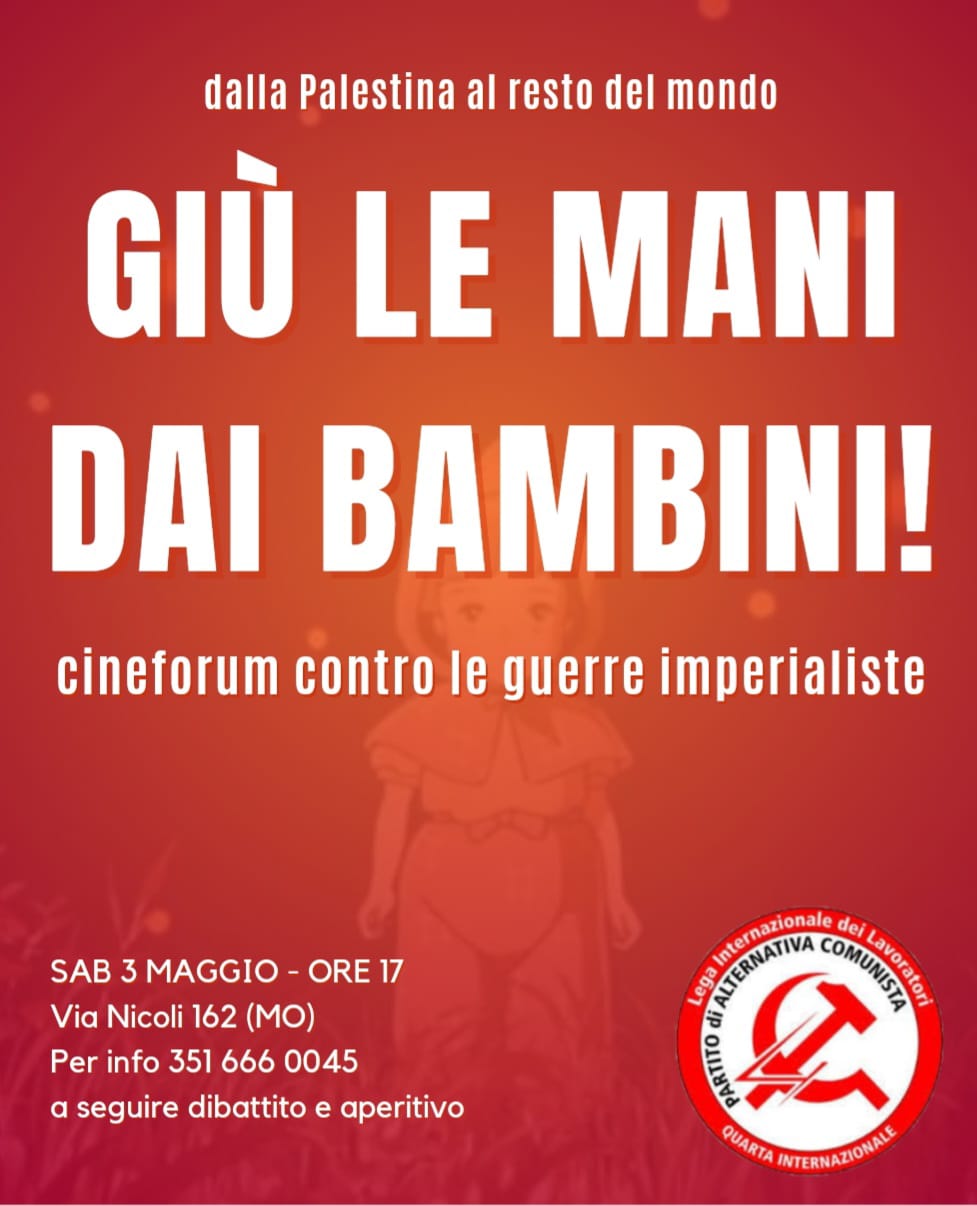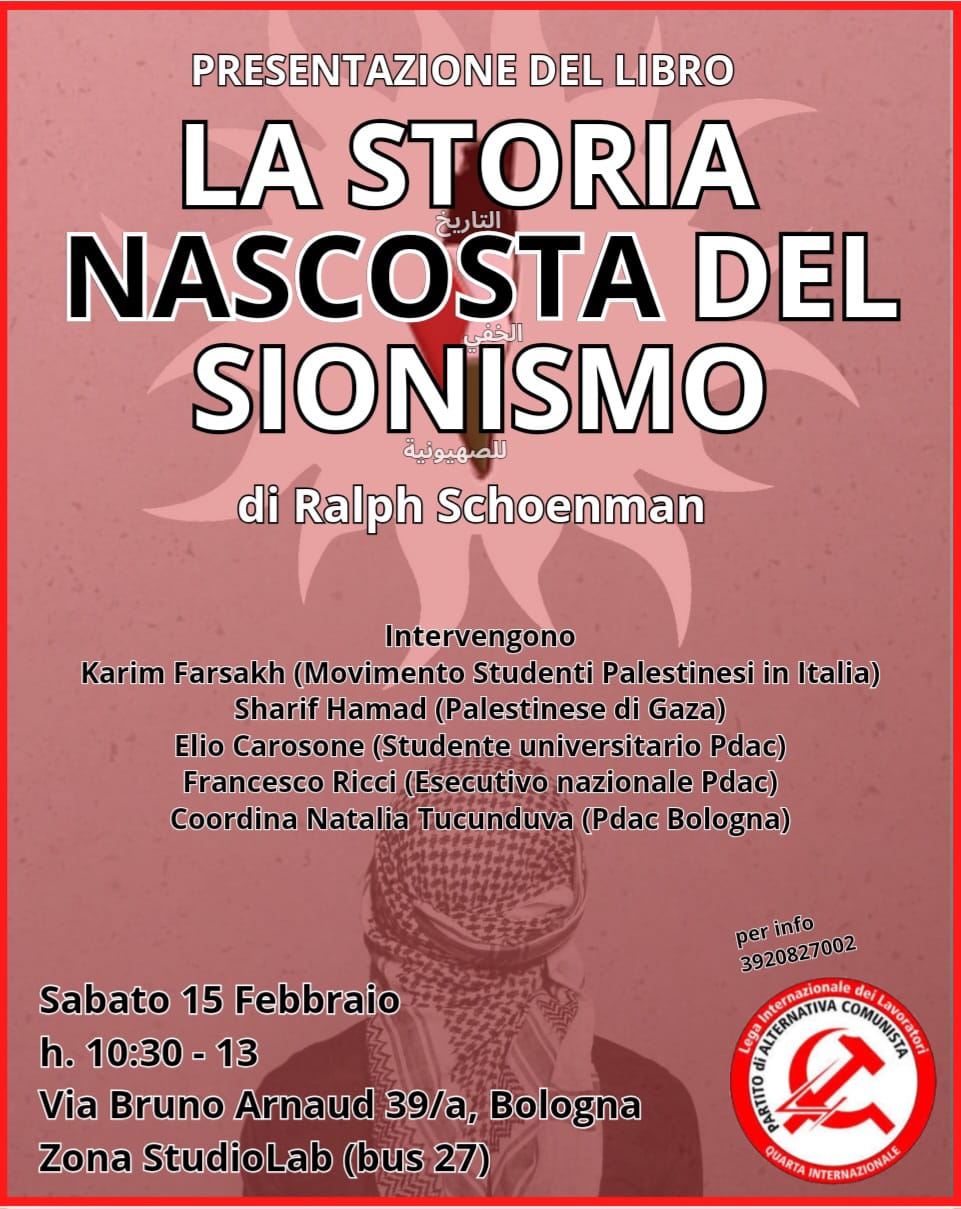Sionismo e pulizia etnica del popolo palestinese
di Soraya Misleh (*)
Il sionismo politico è sorto alla fine del XIX secolo. Il
padre è stato Theodor Herzl, ebreo nato in Ungheria, che svolgeva a Vienna –
allora capitale dell’Impero austro‑ungarico (1867‑1918) – la professione di
giornalista e autore teatrale.
Ben integrato nella società, non nutriva interesse per l’ebraismo
o per questioni ad esso correlate (Shlaim, 2004, p. 38). Il punto di svolta fu,
secondo quanto da lui stesso scritto nel testo Der Jundenstaat (Lo Stato
ebraico)[1], il “Caso”, come fu conosciuto in Francia il caso Dreyfus, cioè
l’accusa di alto tradimento subita nel 1894 in quel Paese dall’ufficiale Alfred
Dreyfus, per essere di origine ebraica. A partire da quest’avvenimento, Herzl
avrebbe concluso che non ci sarebbe stata alcuna speranza di assimilazione;
sicché, l’unica soluzione sarebbe stata che gli ebrei avessero potuto vivere
nel loro proprio Stato. Quest’affermazione, tuttavia, è messa in discussione da
studiosi israeliani (Pappé, 2007, p. 64).
Per garantire l’immigrazione degli ebrei europei verso la
Palestina era necessario convincerli che il trasferimento [2] verso quelle
terre sarebbe stato l’unico modo per liberarsi dell’“antisemitismo” – termine
che si riferisce alla discriminazione contro i semiti. In questo senso, nel
pubblicare nel 1896 Lo Stato ebraico Herzl (1988, p. 47) legò la
cosiddetta “questione ebraica” – a suo dire, un legato del Medioevo – non alla
religione o all’aspetto sociale, ma a un problema nazionale.
Nel suo testo, Herzl non suggerì esclusivamente la Palestina
per la creazione di uno Stato ebraico, ma pose la questione: “Dobbiamo
preferire la Palestina o l’Argentina?”. La sua risposta fu: “La società (ebraica)
accetterà ciò che le daranno, tenendo conto delle manifestazioni dell’opinione
pubblica al riguardo” (1988, p. 66). Nella sua analisi, in entrambi i luoghi
c’erano state esperienze ben riuscite di “colonizzazione ebraica”. Nel 1897,
anno successivo alla pubblicazione del suo scritto, durante il I Congresso
sionista realizzato in Svizzera, a Basilea, in cui si riunirono duecento
delegati dell’est europeo, la scelta finì per ricadere sulla Palestina: “Questo
nome, di per sé solo costituirebbe un potente e trascinante richiamo per l’adunata
del nostro popolo. (…) Per l’Europa rappresenteremmo lì un pezzo di fortezza
contro l’Asia, saremmo la sentinella avanzata della civiltà contro la barbarie.
Saremo uno Stato neutro, in costante relazione con tutta l’Europa, che dovrebbe
garantire la nostra esistenza” (ibidem).
Herzl intraprese ogni sforzo per ottenere l’appoggio delle
élite ebraiche e dei governanti europei al progetto sionista. Secondo Shlaim
(2004, p. 41), il proposito “non dichiarato” – suo e dei suoi successori – era
che il movimento raggiungesse il suo obiettivo “non attraverso un’intesa con i
palestinesi locali, ma attraverso un’alleanza con la grande potenza dominante
del momento”.
Questo partner venne individuato nella Gran Bretagna, che intravvedeva
la Palestina come una sua “futura acquisizione”. Come parte della sua strategia
di convincimento, Herzl spiegò che i britannici avrebbero potuto beneficiare di
una “oasi sionista” nella regione di Gaza, alla quale sarebbe stato necessario
portare acqua dal Nilo attraverso un canale (Pappé, 2007, p. 81). In un primo
momento questo piano venne frustrato in seguito all’obiezione mossa dal Lord inglese
Cromer che comandava al Cairo. In alternativa, Herzl propose la temporanea istituzione
dello Stato ebraico in Uganda, che allora era una colonia inglese, per passare
successivamente in Palestina. Ma ciò fu visto come un tradimento da altri
dirigenti sionisti come Chaim Weizmann (1874‑1952) [3], dal momento che lo
stesso ideatore dello Stato di Israele aveva nazionalizzato l’ebraismo
segnalando il luogo poi definito dal I Congresso sionista. Di conseguenza, il
piano dell’Uganda non fu portato avanti e la Palestina tornò ad essere centrale
nella proposta sionista (ibidem).
Dopo il I Congresso sionista, due rabbini furono inviati in
Palestina per una ricognizione dei luoghi. In un telegramma essi descrissero lo
scenario che il movimento che intendeva creare uno Stato ebraico in quelle
terre si sarebbe trovato di fronte: “La ragazza è bella, ma è sposata con un
altro uomo” (Shlaim, 2004, p. 40). In altre parole, gli esploratori
annunciavano che la Palestina non era una radura, un luogo deserto e
disabitato. Come riferisce Pappé: “Alla vigilia della guerra di Crimea (1853‑1856),
circa mezzo milione di persone viveva in terra di Palestina. Erano di lingua
araba, in maggioranza musulmana, ma circa 60.000 erano cristiani di varie
confessioni e circa 20.000 erano ebrei. Inoltre, dovevano tollerare la presenza
di 50.000 soldati e funzionari ottomani, così come di 10.000 europei (2004, p.
41).
Secondo Schlaim (2004, p. 54), indipendentemente dalla linea
sionista, che comprendeva i cosiddetti laburisti, i moderati e i revisionisti –
il cui fondatore fu l’ebreo russo Zeev Jabotinsky (1880‑1940) – prevaleva
l’idea secondo cui era necessario l’appoggio di una grande potenza per
consolidare il progetto sionista. Così come era necessario stimolare
l’immigrazione ebraica e trasferire i palestinesi nativi usando allo scopo la
forza militare. La differenza era che i revisionisti consideravano
esplicitamente tale opzione.
Nel suo libro Espulsioni dei Palestinesi – Il Concetto di
“trasferimento” nella concezione politica sionista, 1882‑1948, Nur Masalha
presenta una serie di citazioni di dirigenti sionisti che dimostrano la
predominanza dell’idea del trasferimento volontario o coatto della popolazione
araba locale come base per la costituzione di uno Stato esclusivamente ebreo in
Palestina. A suo avviso, quest’idea era stata concepita da tempo. “Theodor
Herzl fornì un riferimento previo al trasferimento, ancor prima di delineare la
sua teoria del rinascimento sionista nel suo Judenstaat” (1993, p. 8).
Sempre secondo Masalha, il 12 giugno del 1895, pensando alla transizione da una
“società di ebrei” a uno Stato, Herzl scriveva nel suo diario: “Quando
occuperemo la terra, porteremo immediatamente vantaggi allo Stato che ci
riceverà. Dobbiamo espropriare con cautela la proprietà privata negli Stati schierati
con noi. Tenteremo, quando la popolazione poverissima varcherà i confini, di cercarle
lavoro nei Paesi che lasciano, mentre le negheremo qualsiasi impiego nel
nostro. I proprietari terrieri saranno dalla nostra parte. Entrambi i processi,
di espropriazione e di rimozione dei poveri andranno messi in atto
discretamente e con circospezione” (ibidem, p. 9).
In un dialogo del 1891 fra due pionieri di Hovevie Zion
(Amanti di Sion) fu altresì esposta l’idea di trasferimento. Uno di essi affermò
che la terra “in Giudea e Galilea è occupata da arabi”. Il suo interlocutore
rispose: “È molto semplice. Li assedieremo finché partiranno. li lasceremo
andare in Transgiordania (l’equivalente dell’attuale Regno di Giordania: ndt)”
(ibidem, p. 9). Sempre secondo Masalha, Israel Zangwill – ideatore
dell’espressione “Una terra senza popolo per un popolo senza terra” – presentò l’espulsione
degli arabi dalla Palestina come una precondizione per la realizzazione del
progetto sionista (ibidem, p. 10). Como indica l’autore, il creatore del
potere militare dello Yishuv [4] e primo premier di Israele, David Ben Gurion,
indicò l’importanza dell’idea di trasferimento in varie citazioni nel suo
diario. In una di esse, il 12 luglio del 1937, affermò: “Il trasferimento
coatto degli arabi dalle vallate dello Stato ebraico proposto ci può offrire
qualcosa che non abbiamo mai avuto [una Galilea libera da arabi], neppure
quando siamo stati padroni del nostro destino nei giorni del Primo e del
Secondo Tempio” (Masalha, 1993, p. 13).
Sempre secondo Masalha, in una lettera a suo figlio Amos del
5 ottobre 1937, Ben Gurion scrisse: “Dobbiamo espellere gli arabi e prendere il
loro posto (…) e se dovremo usare la forza, non per spogliare delle loro
proprietà gli arabi del Negev (deserto localizzato nella parte meridionale
dell’attuale Stato d'Israele: ndt) e della Transgiordania, ma per garantire il
nostro stesso diritto di stabilirci in quei luoghi, useremo la forza”.
Basandosi su documenti ufficiali israeliani, lo storico
Benny Morris ha inizialmente scritto che il trasferimento fino all’espulsione
degli arabi per la costituzione dello Stato ebraico era centrale nel progetto
sionista. Successivamente, in una versione rivisitata della sua opera La
nascita del problema dei profughi palestinesi, ha affermato: “È certo, in
qualche misura, che la prassi del sionismo sia stata caratterizzata all’inizio da
una successione di microcosmici trasferimenti; il conseguimento della terra e
l’insediamento di quasi ogni colonia (moshava) sono stati accompagnati
dal dislocamento o dal trasferimento (legale e normalmente ricompensato) di un
beduino nativo o di una comunità agricola in precedenza insediata. (…) Hess,
Motzkin [5], Ruppin e Zangwill, certamente non pensavano a minidislocamenti, ma
in un massiccio e strategico trasferimento. Tuttavia, nella pratica, l’idea era
considerata, dalla maggioranza dei dirigenti sionisti, come una misura di
dubbia morale. È vero che, per lo meno fino agli anni ’20 e ’30, gli arabi
della Palestina non si vedevano e non venivano considerati da nessuno come un ‘popolo’
distinto. Erano visti come arabi o, più in particolare, come gli ‘arabi siriani
del sud’. Oltre a ciò, il loro trasferimento da Nablus o Hebron verso la
Transgiordania, la Siria e lo stesso Iraq – specie se adeguatamente compensato
– non doveva essere ritenuta un esilio dai luoghi d’origine: gli ‘arabi’
dovevano soltanto essere dislocati da una terra araba ad un’altra” (2004, p.
42).
Secondo l’autore, nella prima metà del XX secolo questo tipo
di trasferimento di “minoranze etniche verso il cuore delle loro aree
nazionali” era “moralmente accettabile, se non addirittura moralmente
auspicabile” e sarebbe stata la soluzione per conflitti futuri. Per Morris, se
durante gli ultimi decenni del XIX secolo e nei primi decenni del XX i sionisti
che peroravano la causa del trasferimento non erano predominanti, all’inizio
degli anni ’30 l’appoggio all’idea si fece largo nella direzione del movimento
e si sviluppò come risposta alle ondate della rivolta araba. A suo avviso, in
seguito all’opportunità apertasi nel 1936 la cupola sionista annunciò la sua
adesione al trasferimento (ibidem, p. 46).
Benché riconosca che le dichiarazioni dei “padri del
sionismo” indichino la strada del trasferimento, Morris confuta nella sua opera
la tesi che il piano di espulsione della popolazione palestinese non ebrea
fosse il fulcro della politica sionista. Nella sua concezione, il
trasferimento, che avrebbe guadagnato consensi a partire dalle rivolte arabe,
fu visto come la soluzione di fronte al rifiuto degli arabi di accettare la
divisione delle loro terre. Così, fu il prodotto della guerra “iniziata dal
lato arabo” nel 1948 (ibidem, p. 60).
Già Masalha riferisce che furono formati comitati di
trasferimento che presentarono diversi piani e proposte ai governo arabi dei
Paesi vicini con l’obiettivo di trasferire i palestinesi non ebrei in generale
verso la Transgiordania, in Siria e in Iraq negli anni ’30 e ’40 (1993, p. 12).
Per Walid Khalidi, l’idea di trasferimento degli arabi
sarebbe un eufemismo in luogo di “pulizia etnica” (1988, p. 5). Il concetto
venne discusso nella Commissione di specialisti dell’Onu nel 1992. Sulla base
delle informazioni fornite da questa commissione, il segretario generale
presentò al presidente del Consiglio di Sicurezza un documento relativo alla
guerra civile in Jugoslavia (1991‑2001) datato 24 maggio 1994 [6]. In esso
viene data questa definizione di “pulizia etnica”, originata da un
“nazionalismo sbagliato”: “rendere un’area etnicamente omogenea grazie all’uso
della forza o dell’intimidazione per rimuovere persone di determinati gruppi”.
Anche sulla base della relazione accompagnatoria, tali atti comprendono la
rimozione forzata della popolazione civile locale in violazione delle leggi
internazionali mediante l’uso di metodi di coercizione come l’assassinio di
massa, la tortura, lo stupro e altre forme di aggressione sessuale; lesioni
corporali gravi a civili; maltrattamenti inflitti a prigionieri civili e di
guerra, utilizzazione di civili come scudi umani; distruzione di proprietà
personali, pubbliche e culturali; saccheggi e furti, espropriazione forzata di
proprietà; massiccio dislocamento della popolazione civile (…) [7].
Sempre nella relazione è specificato che “rappresaglie o
vendette” non possono servire da giustificazione per la violazione delle leggi
internazionali e della Convenzione di Ginevra. Secondo Pappé (2008, p. 19), la
definizione si attaglia a quanto accaduto in Palestina nel 1948, anno di
fondazione dello Stato di Israele: furono stilati piani con l’obiettivo di
preparare le forze paramilitari sioniste per le offensive nelle aree rurali e
urbane dopo che i britannici – che avevano avuto il mandato su quelle terre
come bottino della Prima guerra mondiale (1914‑1918) – avessero lasciato la
Palestina (ibidem, p. 53). I piani erano: A (abbozzato da Elimelech
Avnir, comandante della Haganah [organizzazione paramilitare sionista in
Palestina: ndt], su richiesta di Ben Gurion nel 1937); B (concepito nel 1946);
C (una fusione dei primi due); infine, D (Dalet). In relazione ai primi tre,
Pappé afferma che il proposito era “dissuadere” la popolazione palestinese
dall’attaccare gli insediamenti ebrei e reprimere offensive (2008, p. 53).
Il Piano Dalet
Il piano che pose un sigillo al destino dei palestinesi fu
Dalet. Il nume fu dato dall’Alto Comando sionista (Khalidi, 1988, p. 8).
Secondo Pappé (2008, p. 54), “indipendentemente dalla volontà dei palestinesi
di collaborare od opporsi a questo Stato ebraico, il Piano Dalet si proponeva
la loro sistematica e totale espulsione dalla loro patria”. Estremo e
aggressivo, fu messo a punto in una riunione dei dirigenti sionisti nel locale
che si sarebbe trasformato nel quartier generale della Haganah, la Casa Lilla a
Tel Aviv (attuale capitale israeliana), il 10 marzo 1948 (Pappé, 2008, p. 11).
Questo piano conteneva mappe che indicavano da dove i gruppi paramilitari
avrebbero attaccato ogni villaggio, come sarebbero state queste incursioni, a
partire dalle informazioni di ogni cittadina, mappate negli anni ’40: “Per
elaborare il Piano Dalet, oltre a contare sull’ospitalità dei loro abitanti, i
sionisti crearono una rete di collaboratori. Nonostante il disprezzo che
nutrivano per queste persone – al punto che uno degli accademici coinvolti
nell’elaborazione del piano, Moshe Pasternak, giunse ad affermare che sarebbe
stato difficile avere informatori da loro a causa dei loro costumi primitivi –
ottennero qualche risultato favorevole per le loro intenzioni (Pappé, 2008, p.
43)
Il Piano Dalet fu messo in opera dalle organizzazioni
paramilitari Stern Gang, Irgun e Haganah. Le truppe scelte di quest’ultima – il
Palmach – passarono da 700 membri nel 1941 a 7.000 nel 1948. Successivamente, le
tre organizzazioni si sarebbero fuse per costituire la Forza di difesa di
Israele (Pappé, 2007, p. 143).
Ogni brigata “ricevette una lista dei villaggi che avrebbe
dovuto occupare. La maggioranza dei villaggi era destinata a essere distrutta e
solo in casi eccezionali ai soldati fu impartito l’ordine di lasciarne qualcuno
intatto (ibidem, pp. 164 e 166). La prima operazione, denominata Najsón,
vide la partecipazione non solo di tutti i gruppi paramilitari, ma anche di
ebrei veterani di guerra oriundi dell’Europa orientale e altri appena arrivati.
L’obiettivo fu l’espulsione massiccia della popolazione dalle aree rurali a
ovest delle montagne di Gerusalemme. Il primo villaggio a cadere in
quest’operazione di chiamava Qastal (Il Castello) (Pappé, 2007, p. 129).
Così come Pappé, Walid Khalidi (1988, p. 8) afferma che il
Piano Dalet fu posto in esecuzione con il deliberato obiettivo di espellere la
popolazione araba della Palestina e distruggere questa comunità per mettere in
pratica il progetto sionista di costituzione dello Stato ebreo in quelle terre.
Meron Benvenisti (2002, p. 126) sostiene che, benché gli
obiettivi del Piano Dalet fossero militari, è controverso che mirasse alla
pulizia etnica fino al maggio del 1948: “I comandanti delle forze ebraiche certamente
realizzarono alcuni attacchi i cui obiettivi furono terrorizzare gli arabi
affinché abbandonassero le loro case, ma d’altro canto ci sono parecchie prove
del fatto che i dirigenti ebrei furono sorpresi dall’obiettivo dell’esodo e intrapresero
anche iniziative per persuadere gli arabi a restare nelle loro case” (ibidem,
p. 126).
Secondo Benvenisti, fino alla creazione dello Stato di Israele,
il trasferimento della popolazione araba si verificò come prodotto degli
avvenimenti. Il “trasferimento premeditato” sarebbe stato portato a termine a
partire dall’inizio del giugno 1948 (ibidem, p. 146). Ma secondo Rashid
Khalidi (2006, p. 4), l’argomento dell’esodo degli arabi prima del maggio di
quell’anno come semplice sottoprodotto di una guerra che essi persero
costituisce “la base per negare la responsabilità per i rifugiati”. Per
quest’autore, tale visione ignora il fatto che, in molti casi, i palestinesi
non erano scesi in guerra. E ignora anche la sproporzione delle forze, con lo
Yishuv meglio armato e organizzato (ibidem). Quando, dopo la fondazione
dello Stato d’Israele, il 15 maggio del 1948, i dirigenti arabi decisero di
inviare le loro forze in Palestina, il contingente militare divenne equivalente:
all’inizio, i governi arabi inviarono 25.000 soldati, ma questo numero fu
ampliato di quattro volte nel corso della guerra, equiparandosi agli effettivi
mobilitati dai sionisti (Pappé, 2007, p. 169). Tuttavia, in quel mese, i gruppi
paramilitari ricevettero importanti aiuti per meglio equipaggiarsi: “Durante la
tregua nei combattimenti, gli eserciti arabi non si rifornivano di armi perché
la Gran Bretagna era decisa a osservare l’embargo di armi imposto dall’Onu alle
fazioni in guerra. Le forze ebraiche, dal canto loro, continuarono ad eludere
questo divieto, importando considerevoli quantità di armamenti pesanti dai
Paesi del blocco dell’Est, che violavano il provvedimento dell’Onu. La parità
della prima settimana si trasformò in una superiorità degli ebrei quando ripresero
i combattimenti a metà del mese di giugno del 1948” (Pappé, 2007, p. 171).
L’embargo di armi agli arabi da parte dei britannici si
estese agli eserciti della Giordania, dell’Iraq e dell’Egitto, che utilizzavano
munizioni inglesi (ibidem, p. 168). Secondo Pappé, “c’è da meravigliarsi
che gli Stati arabi siano riusciti a mettere sul campo di battaglia ogni
possibile soldato. Solo alla fine di aprile del 1948, i politici del mondo
arabo prepararono un piano per salvare la Palestina, che in pratica era uno
schema per annettere la maggior parte possibile del suo territorio ai Paesi
arabi che intervenivano in guerra. La maggior parte di questi eserciti
possedeva un’esperienza di guerra molto limitata e un addestramento molto
sommario quando il mandato ebbe fine. Il coordinamento tra di essi era
deficitario, alla pari del morale e delle motivazioni dei soldati, ad eccezione
di un grande gruppo di volontari, il cui entusiasmo non bastava però a
compensare la mancanza di perizia sul campo. (…) Il mondo arabo, i suoi
dirigenti e la società, giurarono di salvare la Palestina. Ma i politici non
erano davvero sinceri. È probabile che i soldati e i loro comandanti mettessero
un impegno più genuino nella salvezza della Palestina (2007, p. 168).
Nel caso della Giordania, ci fu anche un accordo tacito con
Israele alla vigilia della guerra, di spartizione del territorio (ibidem,
p. 178). I dirigenti hashemiti avrebbero di fatto controllato una parte della
Palestina (l’attuale Cisgiordania) fino al 1967, quando essa venne occupata
militarmente da Israele (Tamari, 2002, p. 71). Insieme al futuro Stato ebraico,
avrebbero diviso anche il dominio su Gerusalemme. Altra parte del territorio
(Striscia di Gaza) sarebbe rimasta sotto amministrazione egizia fino a quell’anno
(Hourani, 2007, p. 471).
Sotto la spinta della raccomandazione, fatta dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 29 novembre 1947, di divisione della Palestina
in uno Stato arabo e uno ebraico, il trasferimento dei palestinesi si espanse significativamente.
Secondo la narrativa ufficiale israeliana, l’esodo dei palestinesi si produsse
in conseguenza della guerra
Per Rashid Khalidi (2006, p. 4), quest’argomentazione ignora
soprattutto la necessità del trasferimento degli arabi, che costituivano la
maggioranza della popolazione, per garantire l’istituzione di uno Stato ebraico.
Egli confuta la tesi sostenuta dalla storiografia ufficiale israeliana, secondo
cui i palestinesi lasciarono le loro case per ordine delle loro autorità. Ciò accadde
in pochi casi isolati, come misura di sicurezza per gli abitanti; in generale, invece,
questi dirigenti fecero misero in campo sforzi – “infruttuosi” – affinché la
popolazione restasse (ibidem).
Informative e documenti danno conto delle tattiche
utilizzate dai gruppi paramilitari sionisti. Sulla scorta delle informazioni su
ogni località, mentre in buona parte dei villaggi essi ebbero indicazioni sulla
strategia di attaccare lasciando una sola via d’uscita perché gli abitanti si
dirigessero verso i Paesi arabi vicini, in altra parte si assediava l’intero
territorio non lasciando via di scampo. In questi villaggi i massacri e le
atrocità sono descritti da storici come Ilan Pappé: servirono da propaganda per
espellere i palestinesi che vivevano in insediamenti vicini.
Le operazioni dei gruppi paramilitari privilegiarono
all’inizio i centri urbani come Haifa, allora principale porto del Paese,
destinata nella divisione a far parte del futuro Stato ebraico. L’élite aveva
già abbandonato la città, a partire dai primi attacchi nel dicembre del 1947.
Nell’aprile dell’anno successivo, i sionisti presero la città, il che determinò
l’esodo degli abitanti palestinesi che erano più di 50.000. Altre grandi città,
come Accra e Safed, ebbero lo stesso destino. Neppure Gerusalemme scampò allo
stesso destino: per prenderla, le forze sioniste condussero trenta operazioni
militari, sette delle quali fra il dicembre del 1947 e il maggio del 1948,
tutte in aree che sarebbero state destinate – nella spartizione – allo Stato
arabo (Tamari, 2007, p. 75). I quartieri del lato ovest furono attaccati e
occupati in quel periodo (ibidem, 134‑140). Secondo Tamari, “gli
obiettivi di queste operazioni erano due: 1) spianare la strada fra Tel Aviv,
Jaffa e Gerusalemme per la libera movimentazione delle forze ebraiche; 2) ripulire
le cittadine arabe del lato ovest di Gerusalemme dalla popolazione palestinese
per determinare un deficit demografico e un vincolo tra la proposta dello Stato
ebraico e la città di Gerusalemme, secondo quanto prevedeva il Piano Dalet (ibidem,
p. 75).
Gli inglesi restarono in Palestina fino al 15 maggio 1948 –
un giorno dopo la Dichiarazione di indipendenza di Israele – con la scusa che
le forze ebraiche avrebbero intrapreso una guerra di liberazione nazionale
contro il mandato britannico e per l’ostilità araba (Pappé, 2007, p. 178): “La
perdita dell’1% della sua popolazione [ebraica] avrebbe offuscato la gioia del
conseguimento dell’indipendenza, ma non la volontà e determinazione di
ebraizzare la Palestina e trasformarla in un futuro rifugio per gli ebrei di
tutto il mondo in seguito all’Olocausto”.
Appena partita l’Inghilterra, gli Stati Uniti riconobbero lo
Stato d’Israele. Due giorni dopo, fu la volta dell’Unione Sovietica. In
sequenza, altri Paesi fecero lo stesso. Le conseguenze per i palestinesi non
furono tenute in considerazione (Pappé, 2007, p. 169). In quel momento, due
terzi della popolazione araba locale furono trasferiti. Benché vi fosse la
presenza di decine di osservatori dell’Onu, secondo Pappé (2007, p. 214) essi
non fecero nulla al riguardo. Fece eccezione l’emissario delle Nazioni Unite,
il conte Folke Bernadotte, che propose la revisione della divisione del Paese
in due parti e il ritorno incondizionato dei rifugiati palestinesi. Giunto in
Palestina il 20 maggio 1948, fu assassinato da “terroristi ebrei” nel settembre
dello stesso anno, “quando ripropose la sua raccomandazione nella relazione
finale presentata all’Onu” (Pappé, 2007, p. 214).
In definitiva, vi furono tre fasi di pulizia etnica. La
prima fu inaugurata nel dicembre del 1947, alcuni giorni dopo la suddivisione
raccomandata dall’Onu, e si prolungò fino al maggio del 1948. La seconda, fra
questo mese e il gennaio del ’49, compresi bombardamenti aerei indiscriminati e
cannoneggiamento di quartieri con popolazioni miste. In questa fase, vennero
siglate due tregue e, alla fine, un armistizio fra gli eserciti arabi e Israele
(Pappé, 2007, p. 168). La terza fase del Piano Dalet si prolungò sino al 1954,
benché prima di tale data erano già state distrutte centinaia di villaggi. Gli
storici indicano numeri che variano da 290 a 472 in totale (secondo W. Khalidi,
2006, p. XVI). Pappé (2008, p. 11) indica un numero superiore: 531 villaggi,
oltre allo svuotamento di undici quartieri urbani, per un’espulsione di un
totale di 800.000 palestinesi su circa 1.200.000. Nella parte destinata
dall’Onu alla creazione dell’appena fondato Stato di Israele, di 818.000
palestinesi ne restarono solo 160.000. Al di là delle differenze, sulla base
della metodologia adottata, quel che è certo è che il paesaggio venne
totalmente modificato: “La Palestina si era trasformata in una nuova entità
geopolitica, o meglio, tre entità. Due di esse, la Cisgiordania e la Striscia
di Gaza, erano mal definite: la prima totalmente annessa alla Giordania, ma
senza il consenso o l’entusiasmo della popolazione; la seconda in un limbo,
sotto un regime militare, con i suoi abitanti impossibilitati ad entrare in
territorio egizio propriamente detto. La terza entità era Israele, decisa ad
ebraizzare ogni parte della Palestina e a costruire un nuovo organismo vivo, la
comunità ebraica di Israele (Pappé, 2007, p. 178).
(*) Dal sito della Lit-Quarta Internazionale
Articolo basato sulla dissertazione della tesi universitaria intitolata “Qaqun: storia ed esilio di una piccola contrada palestinese distrutta nel 1948” e discussa nel dicembre del 2013 nella Facoltà di Filosofia, Lettere e Scienze Umane dell’Università di San Paolo (Usp), insieme al Dipartimento di Lettere Orientali, sotto la direzione della professoressa Arlene Elizabeth Clemesha.
(traduzione di Valerio Torre)
Bibliografia
BENVENISTI, Meron. Sacred Landscape – The Buried History of the Holy Land since 1948. Translator: Maxine Kaufman-Lacusta. California: University of California Press, 2002.
HERZL, Theodor. O estado judeu. Trad. David José Perez. Rio de Janeiro: Garamond, 1998.
HOURANI, Albert. Uma história dos povos árabes. Trad. Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
KHALIDI, Rashid. The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for Statehood. New York: Columbia University Press.
KHALIDI, Walid. All that Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948. Washington: Institute for Palestine Studies, 1998.
KHALIDI, Walid. Plan Dalet: master plan for the conquest of Palestine.Journal of Palestine Studies. Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/23122101/Walid-Khalidi-Plan-Dalet-Master-Plan-for-the-Conquest-of-Palestine. Acesso em: 26 mai. 2012.
MASALHA, Nur. Expulsion of the Palestinians: The Concept of “Transfer” in Zionist Political Thought, 1882-1948. Washington: Institute for Palestine Studies, 1992.
MORRIS, Benny. The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited, 1947-1949. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
PAPPE, Ilan. História da Palestina moderna – uma terra, dois povos. Trad. Ana Saldanha, Lisboa: Ed. Caminho, 2007.
_______. La limpieza étnica de Palestina. Trad. Luis Noriega, Barcelona: Memória Crítica, 2008.
_______. The Forgotten Palestinians – A History of the Palestinians in Israel. London: Yale UniversityPress, 2011.
SHLAIM, Avi. A muralha de ferro – Israel e o mundo árabe. Trad. Maria Beatriz Penna Vogel. Rio de Janeiro: Fissus Ed., 2004.
TAMARI, Salim (ed.), Jerusalem 1948 – The Arab Neighbourhoods and their Fate in the War. The Institute of Jerusalem Studies & Badil Resource Center, Second Revised Edition, 2002.
Note
[1] Lo scrittore Moacyr Scliar (1937-2011), che partecipò al movimento giovanile sionista, affronta il tema nei suoi commentari all’edizione portoghese de Lo Stato ebraico. HERZL, T. O Estado judeu. Trad. David José Pérez. Rio de Janeiro: Garamond, 1998, p. 21.
[2] Il termine sarebbe stato usato come eufemismo dai sionisti secondo MASALHA, N. Expulsion of the Palestinians: The Concept of “Transfer” in Zionist Political Thought, 1882-1948. Washington: Institute for Palestine Studies, 1993.
[3]Chaim Weizmann sarebbe poi stato il primo presidente di Israele, nel 1948. Disponibile in:
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/weizmann.html.
[4] Comunità ebraica. PAPPÉ, I. História da Palestina moderna – uma terra, dois povos. Trad. Ana Saldanha, Lisboa: Ed. Caminho, 2007, p. 358.
[5] Leo Motzkin, presidente del Consiglio Generale dell’Organizzazione mondiale sionista. Disponibile in: http://www.jta.org/1932/05/23/archive/zionist-movement-and-french-report-mr-motzkin-president-of-zionist-general-council-leaves-for-pale>.
[6] Disponibile in: http://www.icty.org/x/file/About/OTP/un_commission_of_experts_report1994_en.pdf.
[7] Idem.