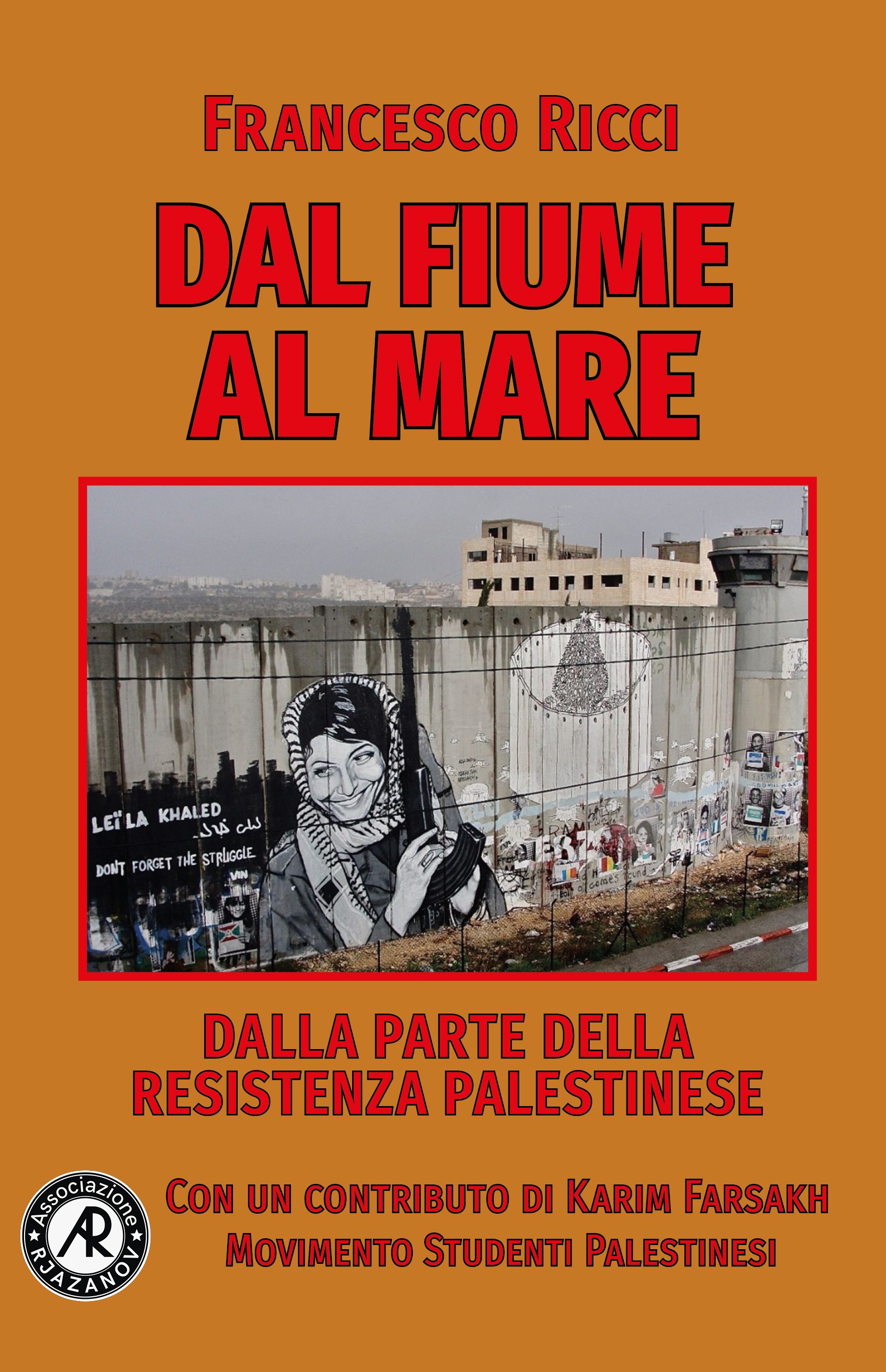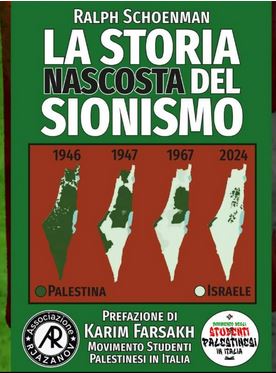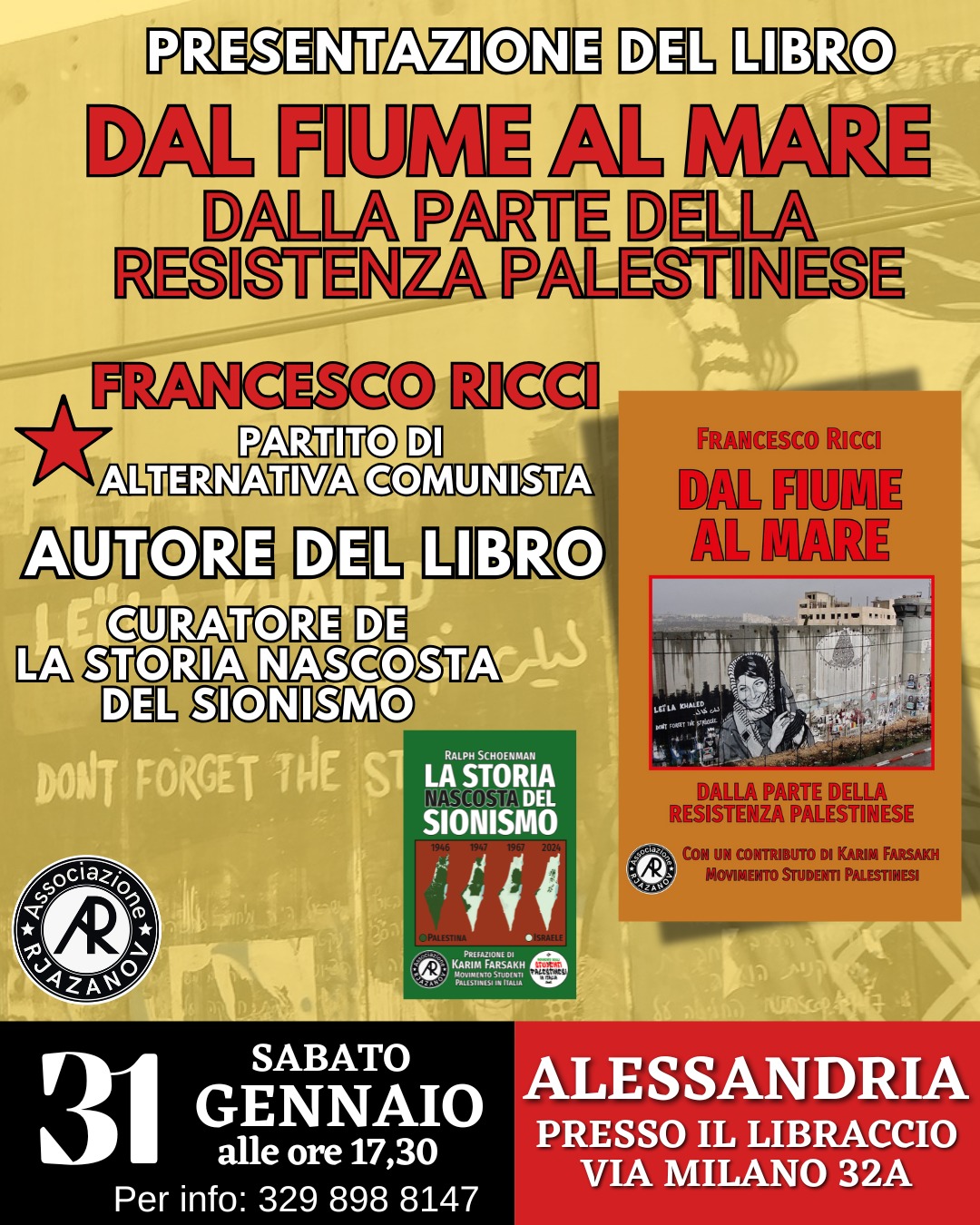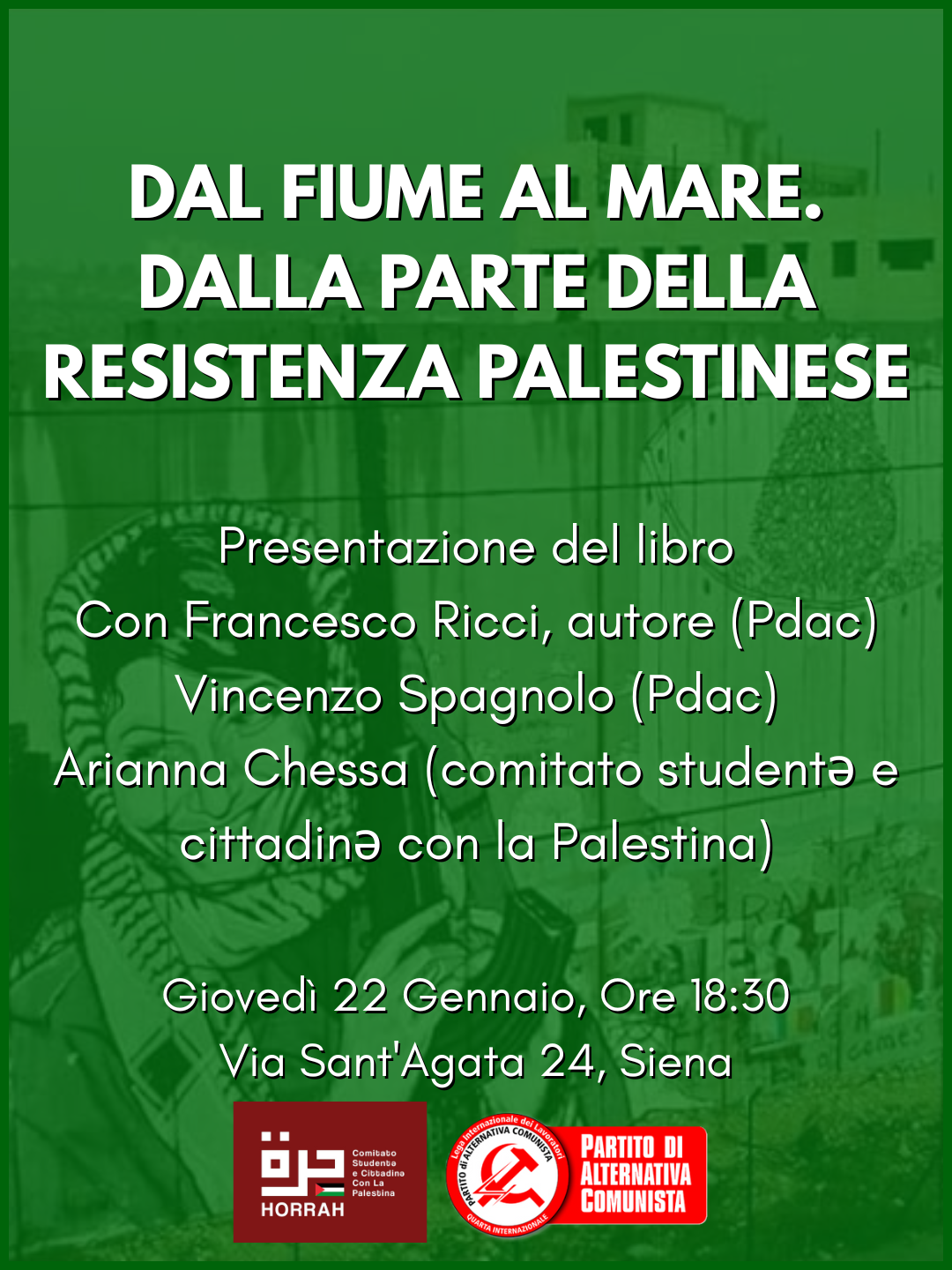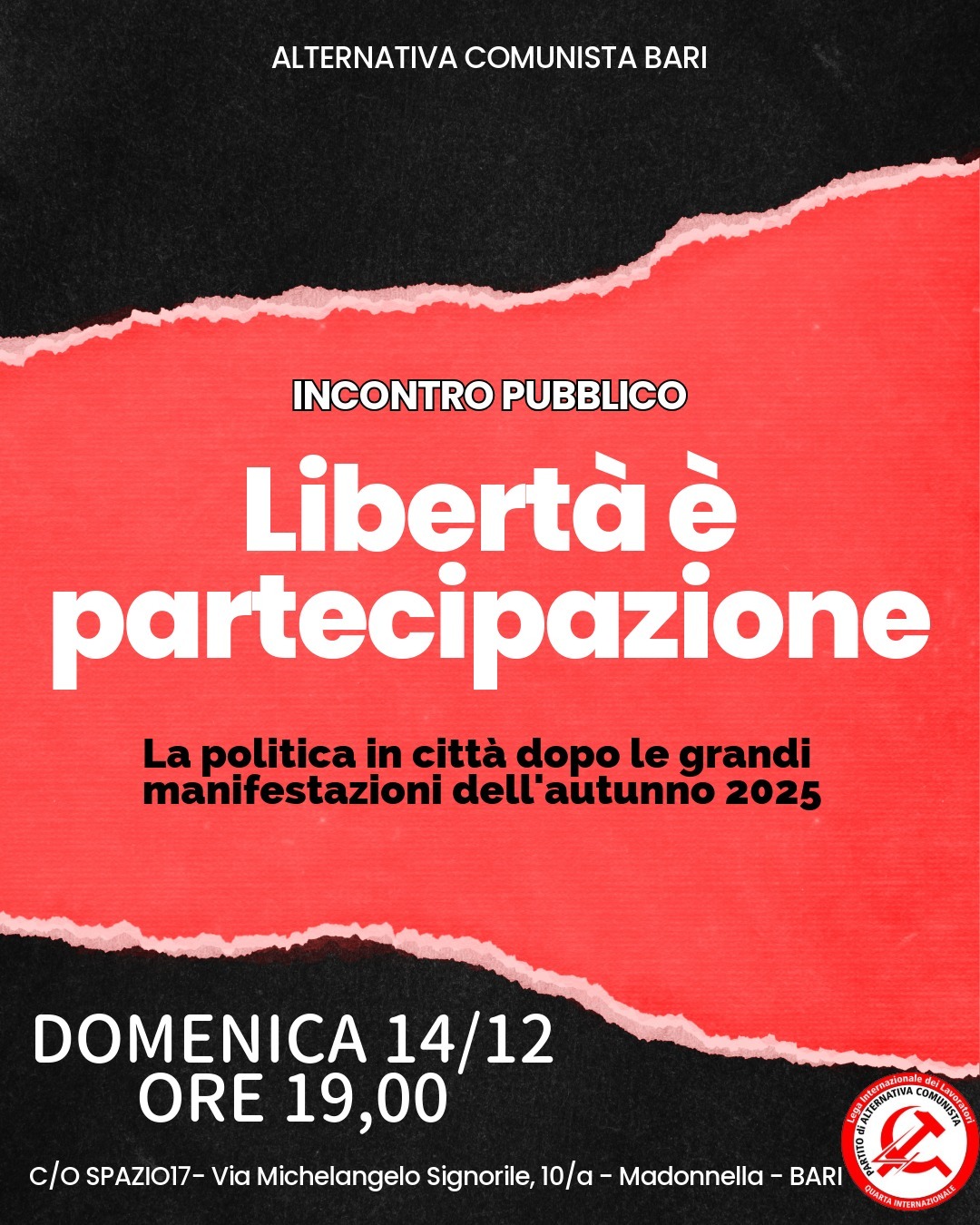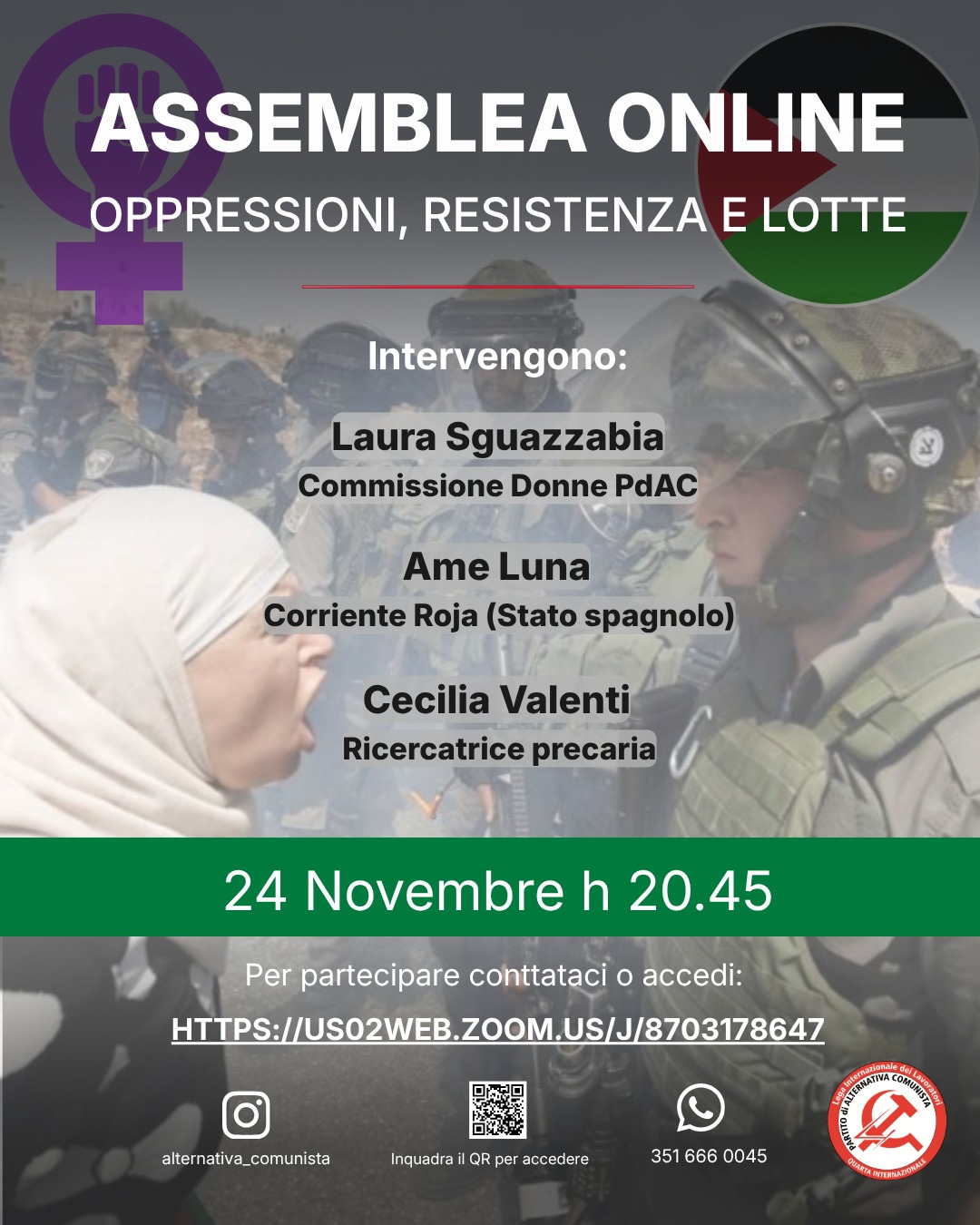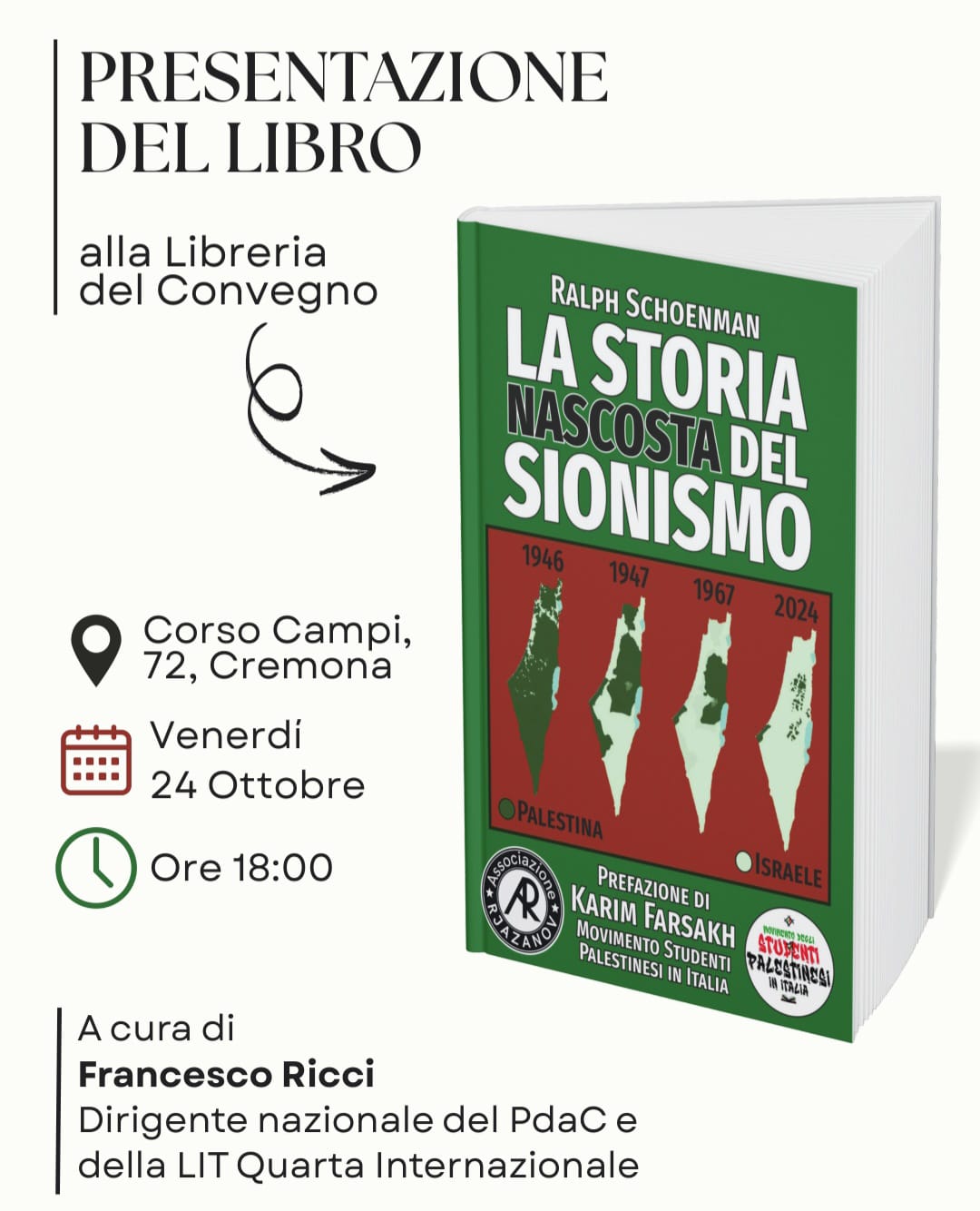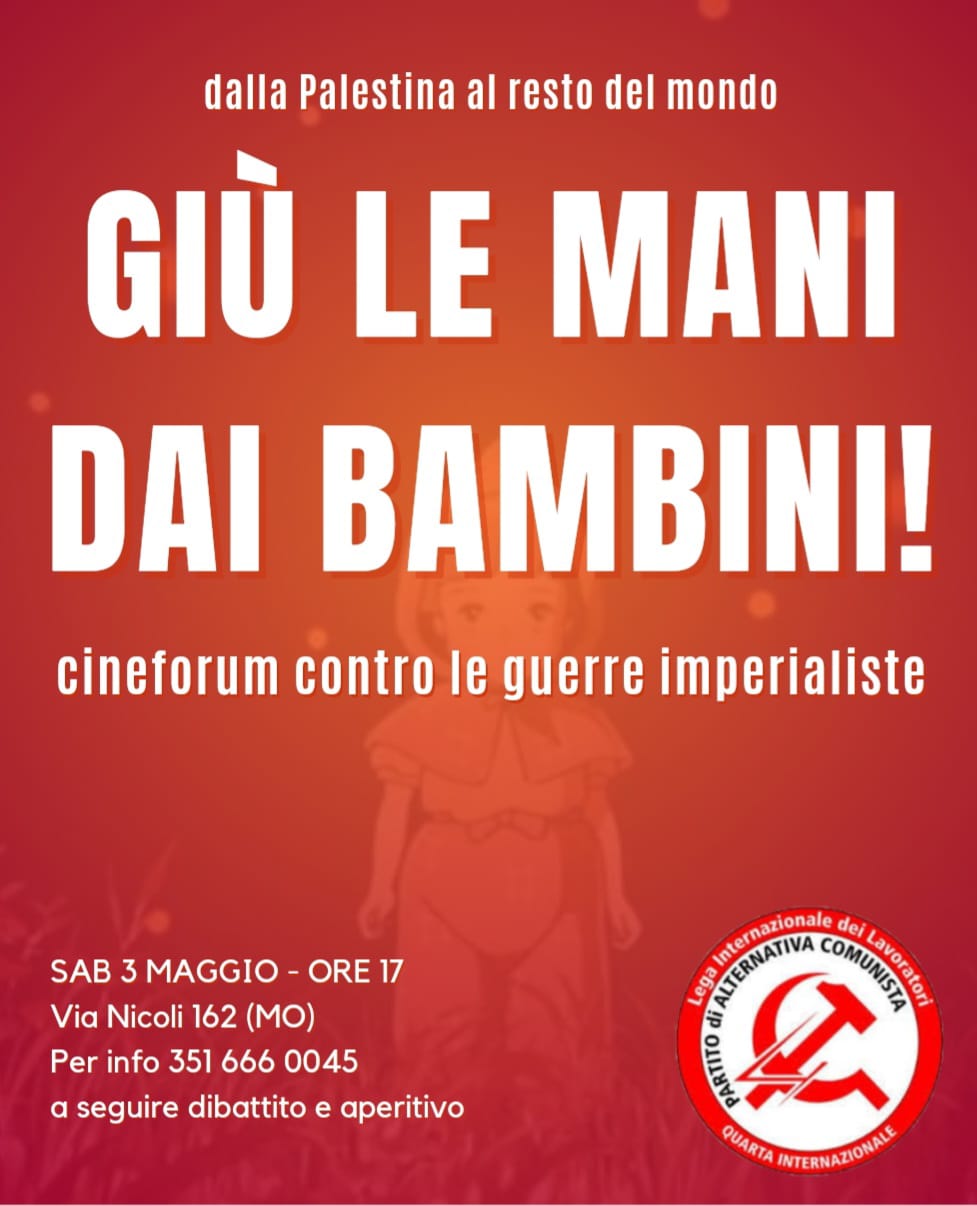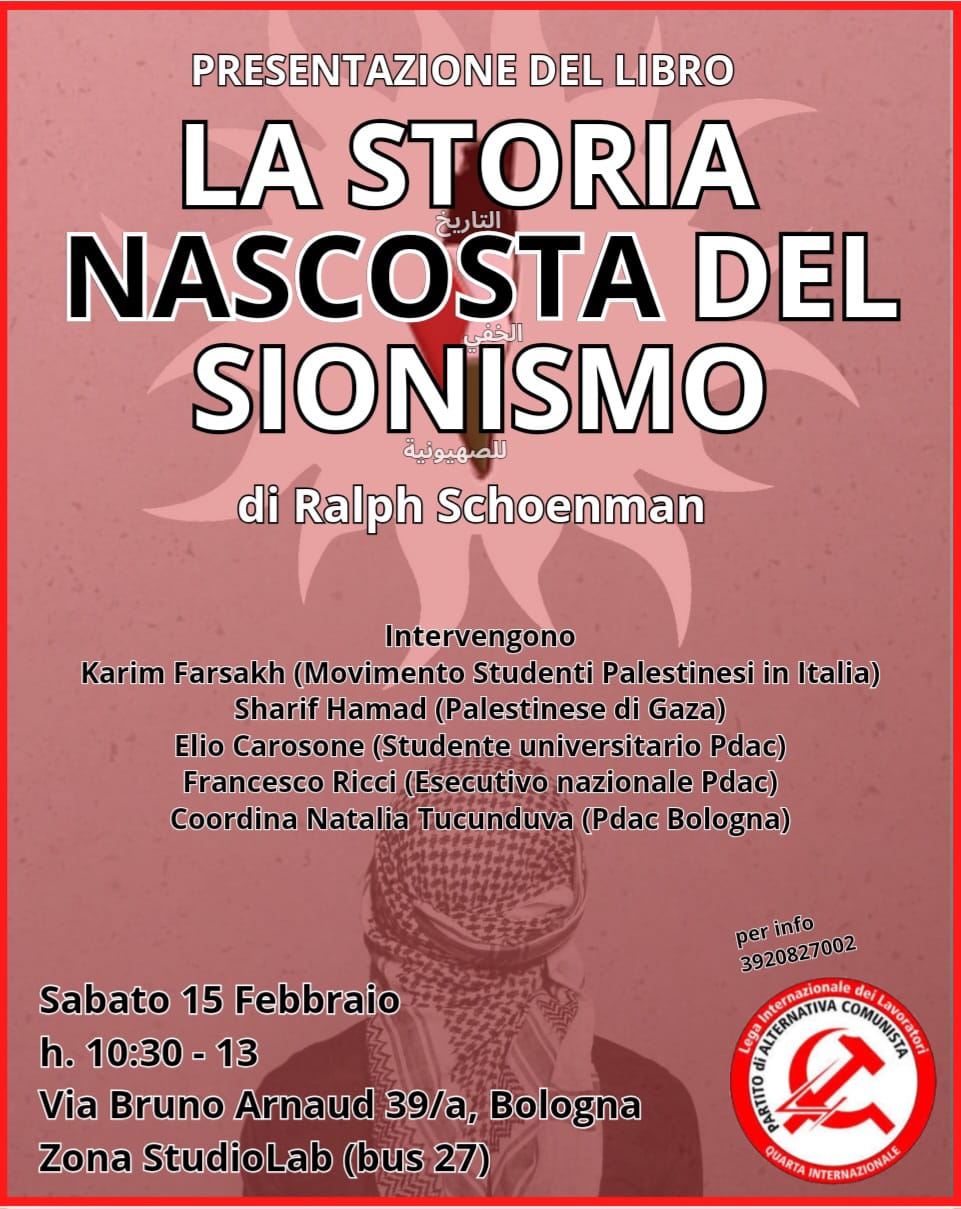A 25 anni dalla caduta
del Muro di Berlino
di Alicia Sagra
(dal sito della Lit - Quarta Internazionale)
Lo
scorso nove novembre è stato il venticinquesimo anniversario della caduta del
Muro di Berlino. Cinque
anni fa, in occasione del ventennale, Alicia Sagra del PSTU di Argentina ha
scritto questo articolo che mantiene la sua piena attualità.
Il
9 novembre 1989, accadde un avvenimento che commosse il mondo: la caduta del
Muro di Berlino. Quel giorno, durante una conferenza stampa, venne dato
l'annuncio ufficiale che a partire dalla mezzanotte i tedeschi dell'Est
avrebbero potuto attraversare qualsiasi frontiera della Repubblica Democratica
Tedesca (RDT), compreso il Muro di Berlino, senza l'obbligo di possedere
permessi speciali.
La
notizia si diffuse immediatamente in entrambe le parti della città divisa:
molto prima della mezzanotte migliaia di berlinesi si erano radunati su
entrambi i lati del muro. Giunto il momento tanto atteso, i berlinesi dell'Est
iniziarono a passare il posto di blocco. Abbondarono le scene colme di
emozione: abbracci di familiari e amici che erano rimasti per tanto tempo
separati, lacrime, volti che manifestavano incredulità, brindisi con champagne
o birra, regali di benvenuto ai visitatori, fiori sui parabrezza delle auto che
passavano la frontiera e nei fucili dei soldati che presidiavano i posti di
sorveglianza. Di lì a poco le scene che avrebbero fatto il giro del mondo:
migliaia di giovani che buttano giù il muro a martellate.
Si
era realizzata una grande rivendicazione nazionale che sussisteva da quando, il
13 agosto 1961, i leader della vecchia Repubblica Democratica Tedesca (RDT)
avevano ordinato la costruzione di una parete di calcestruzzo di 166 chilometri
di lunghezza e quattro metri di altezza per dividere in due la città di
Berlino.
Non fu una concessione delle autorità
La
caduta del Muro fu il culmine di un processo rivoluzionario che si andava
sviluppandosi e che si manifestava in vari modi: aumentarono le fughe e i
tentativi di fuga dalla Germania dell'Est: alcuni tentavano di attraversare il
Muro, la maggior parte andava in Ungheria, dove il 2 maggio i soldati ungheresi
avevano iniziato ad abbattere le frontiere con l'Austria. Per questa via, entro
la metà di settembre, 15 mila tedeschi orientali avevano raggiunto la Germania
Federale.
A
partire da ottobre si svolsero grandi marce in diverse città della Germania
dell'Est. Dapprima a Lipsia; poi, di settimana in settimana, le marce andarono
generalizzandosi in varie città, mentre aumentava il numero dei manifestanti.
Il 18 ottobre il presidente Honecker, che aveva cercato di rispondere con la
repressione, fu spogliato di tutti i suoi incarichi e rimpiazzato da Egon
Krenz, il vecchio capo della sicurezza. Krenz cercò di riappacificare i
manifestanti, ma non vi riuscì. Il 23 ottobre si mobilitarono 200 mila persone
e il 6 novembre il numero salì a quasi 500 mila.
Dinanzi
a questa inarrestabile situazione, il 7 novembre si dimise l'intero Consiglio
dei Ministri, l'organismo che reggeva il destino della RDT. Due giorni dopo
cadeva il Muro di Berlino.
Non fu un fenomeno isolato
Al contrario, la caduta del Muro fu il simbolo di un impressionante processo rivoluzionario di massa diretto contro i regimi totalitari a partito unico dell'Europa dell'Est, che caddero uno dopo l'altro come castelli di carte.
In Polonia, dopo un gran numero di scioperi causati dalle insostenibili condizioni di vita, i dirigenti del sindacato Solidarność (che 7 anni prima era stato messo fuori legge) negoziarono con il governo una legislazione sindacale, modifiche istituzionali e libere elezioni. Nelle elezioni del luglio 1989 i candidati di Solidarność si imposero ampiamente sia al Senato che alla Camera; in agosto Tadeuz Mazowiecki, editore del periodico di Solidarność, divenne primo ministro della Polonia.
In
Cecoslovacchia, il 21 agosto 1989, migliaia di manifestanti si
lanciarono nelle strade nel ventunesimo anniversario dell'invasione della
Cecoslovacchia da parte delle truppe del Patto di Varsavia. A metà novembre si
formò un'assemblea di studenti che marciarono verso Piazza San Venceslao
manifestando il proprio scontento per il sistema imperante. La polizia
antisommossa li attaccò brutalmente, ma nei giorni seguenti migliaia di
cittadini si riunirono nella stessa piazza per protestare contro la repressione
ed esigere elezioni libere e la destituzione del presidente. Il Partito
Comunista dovette cedere il potere ad una maggioranza che non controllava. Il
nuovo gabinetto, insediatosi a dicembre, contava undici rappresentanti non
comunisti. Fu peraltro legalizzata la formazione di partiti di opposizione.
In
Ungheria il processo cominciò in anticipo. Già nel 1988 era stato
destituito il primo ministro János Kádar, sostituito da Karoly Grosz. Nel
maggio del 1989 il governo ordinò all'esercito di iniziare a smantellare la
recinzione in filo spinato che marcava la frontiera con l'Austria, fatto che,
come abbiamo visto, catalizzò il processo tedesco. Il 10 giugno il Partito
Comunista Ungherese e l'opposizione firmarono un accordo che sancì la
transizione verso il multipartitismo. Tutto ciò fu il prodotto di grandi
mobilitazioni di massa che ebbero però un carattere non violento, da cui la
definizione (che inizialmente fu attribuita esclusivamente al processo
cecoslovacco) di “rivoluzioni di velluto”. Ma ci fu un caso differente.
In
Romania, dal 1972, il presidente Nicolae Ceausescu governava col pugno di
ferro. Non tollerava nessuna critica, nel Paese come nel partito. I suoi
familiari, sua moglie e suo figlio occupavano posti chiave nel governo, ed
erano noti i fatti di corruzione in cui erano coinvolti. A metà dicembre del
1989 si diedero manifestazioni di protesta contro il governo. Ceausescu, che
diede l'ordine di reprimerle, non fu ascoltato dai soldati, molti dei quali
passarono dall'altra parte della barricata. Le masse popolari rumene accorsero
in gran numero a festeggiare il trionfo. Ma il 21 dicembre le truppe speciali
rimaste fedeli al governo realizzarono una sanguinosa repressione a Bucarest e
in altre città.
Ciò
provocò la violenta reazione del movimento di massa, che contava sul sostegno
di un settore dell'esercito. A seguito di violenti scontri, il 23 dicembre il
presidente e sua moglie furono catturati, accusati di abuso di potere e
dell'uccisione di 60 mila rumeni. Due giorni dopo furono giustiziati. Andò al
potere il Fronte di Salvezza Nazionale, costituito da vecchi membri del Partito
Comunista che si erano opposti a Ceausescu e da professionisti e intellettuali
dissidenti.
L'intero processo contro i regimi a partito unico culminò nel 1991 con la caduta del regime sovietico.
Il carattere di queste mobilitazioni
Sulla
base di questi fatti, i propagandisti dell'imperialismo lanciarono una grande
campagna sul “fallimento del socialismo e la supremazia del capitalismo”.
Questo slogan fu ribadito dall'attitudine dei partiti comunisti, che piangevano
la caduta di questi regimi e parlavano di una “terribile sconfitta mondiale”.
La
Lit, in un primo momento, mantenne una posizione diametralmente opposta: questi
regimi non erano stati rovesciati dall'imperialismo ma dalle mobilitazioni
delle masse che manifestavano per le proprie condizioni di vita. Di conseguenza
la loro caduta aveva un carattere altamente rivoluzionario, che portò alla
distruzione del centro mondiale dello stalinismo, che si era convertito nella
camicia di forza della classe operaia e del movimento di massa di tutto il
mondo.
Ma
tra le organizzazioni trotskiste, che in generale mantenevano questa posizione
(anche in seno alla Lit dell'epoca), si aprì una grande polemica sulle
conseguenze di questi processi. Qual era il fatto predominante? La distruzione
dell'apparato stalinista o la restaurazione del capitalismo che si diede in
tutti questi Stati operai degenerati?
Martín
Hernández, nel suo libro El veredicto de la Historia [Il verdetto della
Storia, 2009], dà un'interpretazione di questi fatti.
Quali conclusioni dobbiamo trarne?
I
processi dell'Est aprirono grandi polemiche nell'avanguardia operaia e di
sinistra a livello mondiale. Dopo 20 anni, nel mezzo della crisi globale del
capitalismo, godiamo di una migliore prospettiva storica per riprendere il
dibattito. Furono molte le organizzazioni colpite da questi grandi eventi. Lo
furono i partiti comunisti che videro crollare, uno dopo l'altro, i propri sostegni
politici e, molte volte, materiali.
Ma
lo furono anche molte delle organizzazioni trotskiste. Il caso estremo fu
quello del cosiddetto Segretariato Unificato (SU), che arrivò alla conclusione
che, con la caduta del Muro, venissero meno le barriere tra rivoluzionari e
riformisti, cancellando dal proprio programma la lotta per la dittatura del
proletariato ed entrando a far parte di governi borghesi.
Altri,
come il MST (movimento argentino), pur essendo meno espliciti giunsero a
conclusioni che finirono col portarli sulla stessa strada. A loro avviso, i
grandi cambiamenti del '89-91 ci obbligano ad essere più flessibili, ad
abbandonare l'“ortodossia”. Per questo ora costruiscono partiti assieme ai
riformisti (come il PSOL brasiliano) e anche con rappresentanti della borghesia
(come si è cercato di fare in Argentina con il peronista cattolico Mario
Cafiero), appoggiando governi borghesi come in Venezuela. E alle loro spalle vi
è un intero plotone composto da differenti organizzazioni che, poco a poco, hanno
trasfigurato gli obiettivi, la ragion d'essere, della loro militanza.
L'attività
elettorale ha acquisito valenza basilare. La logica delle elezioni si è imposta
sulla logica delle lotte. L'unità per lottare è divenuta secondaria (viceversa
l'unità per andare al governo con la borghesia è diventata imprescindibile,
ndt). Se si vince o meno una lotta, se la classe si rafforza o si debilita, è
secondario; ciò che conta è che si rafforzi l'apparato di partito e quante
volte si compare in tv.
Vi
sono sempre state organizzazioni che hanno agito in questo modo, ma
all'indomani dei processi dell'Est tutto ciò si è generalizzato. È avvenuto
perché, più o meno coscientemente, questi settori hanno finito con
l'abbandonare la prospettiva della rivoluzione. Alcuni perché pensano non sia
più necessaria, altri non giudicandola più fattibile, hanno abbandonato la
lotta per il potere per dedicarsi a “costruire il potere” all'interno del
capitalismo o a fare propaganda su un indefinito futuro socialista.
In
un modo o nell'altro queste organizzazioni sono state colpite dall'“alluvione
opportunista” alimentata dalla campagna imperialista secondo cui “il socialismo
è morto”. La Lit non è sfuggita a questa alluvione, ne è uscita anzi distrutta.
E la nostra ricostruzione è stata resa possibile, innanzitutto, da una corretta
interpretazione di questi fatti, che ci ha permesso non di rifiutare ma al
contrario di verificare l'enorme attualità del trotskismo e della prospettiva
della rivoluzione socialista.
Restaurazione e rivoluzione
Martín
Hernández, nel suo libro El veredicto de la Historia, sostiene che: «La
mancanza di chiarezza sui diversi momenti dei cosiddetti “processi dell'Est” è
stata, e continua ad essere, fonte di enormi confusioni. […] Si organizzano di
solito interminabili dibattiti. […] E sorge inevitabilmente la domanda: dal
punto di vista degli interessi dei lavoratori quanto accadde nell'Est europeo
fu positivo o negativo? Questo tipo di domanda presuppone in genere la credenza
che furono le mobilitazioni, nella lotta contro la burocrazia, a buttar giù
quel che restava degli stati operai, “gettando via il bambino con l'acqua
sporca”. Ma non fu così […]
Se
osserviamo gli avvenimenti dal punto di vista storico, vediamo che nel corso di
decenni vi erano stati vari tentativi di abbattere la burocrazia. Questi
tentativi furono sconfitti, la burocrazia restò al potere e portò alla
restaurazione del capitalismo. Questo fatto fu, senza dubbio, estremamente
negativo. È in fondo la massima espressione della crisi di direzione
rivoluzionaria. Se la storia si fosse fermata lì, oggi saremmo probabilmente
dinanzi ad una delle più grandi sconfitte della storia del proletariato
mondiale. Ma la storia non si fermò lì. Dopo il ritorno al potere della
borghesia, le masse si riversarono nelle strade e rovesciarono i suoi agenti, e
con loro i regimi dittatoriali, stalinisti, a partito unico. E questo è
ovviamente positivo. […]
Il
crollo dell'apparato stalinista è una vittoria immensa della classe operaia
mondiale, grande quanto la sconfitta del fascismo durante la Seconda Guerra
Mondiale. La mancanza di una direzione rivoluzionaria fece sì che
l'abbattimento dei regimi stalinisti desse luogo a regimi democratico-borghesi
e non a dittature rivoluzionarie del proletariato. Ma ciò non significa che
siamo di fronte ad una sconfitta. […]
Ma
perché di solito, a livello del trotskismo ortodosso, si sostiene il contrario?
Perché si parte dalla falsa idea secondo cui furono le masse a rovesciare una
dittatura burocratica del proletariato e a sostituirla con un regime
democratico-borghese. Ma non è così. Le masse rovesciarono dittature borghesi
(tali erano dalla metà degli anni 80), il che fu una vittoria colossale ma a
causa della mancanza di una direzione rivoluzionaria, la borghesia e i suoi agenti
riuscirono ad imporre regimi democratico-borghesi.»
Sulla
base della sua indagine, Martín Hernández arriva alla conclusione che il
verdetto della storia ha confermato le previsioni di Trotsky e che i processi
dell'Est, anziché allontanare la prospettiva rivoluzionaria, offrono condizioni
più favorevoli per la classe operaia e le masse. La distruzione dell'apparato
stalinista apre maggiori possibilità per avanzare nella risoluzione della crisi
rivoluzionaria, dalla quale in ultima istanza tutto dipende.[...]
Cuba: dalla rivoluzione socialista alla restaurazione capitalista
Nei
giorni scorsi, è stata pubblicata la notizia (La Nación, 11/10/2009), che a
Cuba sarebbe stata cancellata la tessera di razionamento, uno dei simboli del
cosiddetto “socialismo cubano”. Con questa tessera si garantiva all'intera
popolazione la provvista mensile di 2,25 chili di riso, 1,4 chili di zucchero,
1,8 chili di grano, 0,2 chili di olio, 112 grammi di caffè, 10 uova e 450
grammi di sale fino, così come un sapone da bagno e un tubo di dentifricio
trimestralmente. Sebbene insufficiente, era un palliativo per coloro che
guadagnano salari estremamente bassi.
Già
nel febbraio 2008, Raul Castro sosteneva che i servizi gratuiti, i sussidi e
l'equa distribuzione dei prodotti attraverso la tessera di razionamento, erano
“irrazionali e insostenibile” nelle attuali condizioni dell'economia nazionale.
Tutto
questo porta molti rivoluzionari a pensare che è Raul Castro che sta
introducendo l'economia capitalista nell'isola. Non è la visione di Martin
Hernandez. In un dibattito con i dirigenti cubani, riprodotto nel libro che
presentiamo, egli dice:
«A
Cuba, con la rivoluzione, è sparita la disoccupazione! A Cuba, con la
rivoluzione, sono spariti i problemi della sanità! A Cuba si è conquistata
l'assistenza sanitaria che tutti vogliamo, l'assistenza sanitaria per tutta la
popolazione e non solo per i privilegiati e, più ancora, si sono fatti passi in
avanti impressionanti nel campo della ricerca medica e farmacologica. Ma le conquiste
non sono state solo nel campo della medicina, ma in settori come l'alloggio e
l'istruzione. E questi sviluppi hanno avuto i loro riflessi anche in altre
campi, come ad esempio lo sport. [...] Questi enormi successi, che sono stati
possibili grazie alla rivoluzione, all'espropriazione dell'imperialismo e del
capitalismo, oggi si stanno perdendo [...] Non c'è più l'economia pianificata.
Non c'è più il monopolio del commercio estero. E non esiste più l'economia
statalizzata, esiste solo in minima e decrescente parte. Quindi, a mio parere,
ciò che sta accadendo a Cuba è la restaurazione del capitalismo. Un
restaurazione che non avviene per un'invasione di “gusanos” (vermi, spregiativo
riferito agli esuli anti-castristi negli USA), ma da parte dello stesso governo
cubano.»
Il
dibattito di cui parliamo si diede nel 2001, cioè quando il governo cubano era
guidato da Fidel. Questa interpretazione di Martín Hernández, può spiegare
perché gli attuali cambiamenti operati da Raul Castro, si realizzano senza
alcuna opposizione da parte di suo fratello. Sappiamo che questo è un tema
molto polemico.
(traduzione dallo spagnolo di Giovanni "Ivan" Alberotanza)